Il compositore piemontese è uno dei più interessanti esponenti della musica contemporanea italiana e in questa lunga e articolata intervista ci spiega la sua concezione estetica e artistica, foriera di numerosi spunti interdisciplinari e basata su un affascinante principio di analisi e (ri)sintesi che scaturisce dalla lezione dei gradi autori del passato

Maestro Verlingieri, il suo processo compositivo si basa su un principio di analisi e (ri)sintesi. In che cosa consiste esattamente e come si attua, nella sua musica, la ricerca della tradizione dei suoni del passato con quelli che sente in sé, espressione del tempo che vive come uomo e come artista?
Comincerò dalla fine della sua stimolante domanda. Viviamo in un’epoca che definirei “della riproducibilità virtuale dell’opera d’arte”, espandendo il concetto di “riproducibilità tecnica” reso famoso dal filosofo Walter Benjamin in un periodo storico in cui il “qui e ora” della musica, come lo definiva lo stesso filosofo tedesco, ossia l’unicità dell’ascolto della musica nel luogo e momento preciso in cui veniva eseguita dal vivo, vacillava a colpi di radio e dischi 78 giri in gommalacca che appunto rendevano la musica “riproducibile tecnicamente”. A quella che fu una vera e propria rivoluzione ne sono seguite altre, e non solo l’avvento di internet da rete fissa e successivamente in versione mobile ha reso i contenuti artistici raggiungibili ovunque, da chiunque e in qualunque momento (tanto da quasi annullare le dimensioni spaziale-geografica e temporale-storica della cultura e permettendoci viaggi virtuali istantanei lungo entrambe), ma proprio la realtà virtuale oggi ci consente di vivere esperienze ancor più immersive in tal senso, comodamente dal salotto di casa.

Muoversi a piacere all’interno delle sale ricostruite in realtà virtuale di un museo dall’altra parte del mondo, come a volte faccio con mio figlio di due anni in braccio, in attesa di potercelo portare realmente, sederci a fianco degli orchestrali in una sala da concerto anch’essa virtuale, e quant’altro: il passo è breve rispetto al creare mondi - sempre virtuali s’intende - paralleli e immaginari, dove concetti e culture assai diversi, anche agli antipodi tra loro, si ritrovino appaiati, intersecati, collegati in un fluire liquido (facendo il verso questa volta a un altro grande intellettuale che amo, il sociologo e filosofo Zygmunt Baumann). Liquido, sì, e anche assai rapido, questo flusso può comunque sedimentare e stratificarsi con facilità nella nostra mente, ecco l’aspetto che mi colpisce! La mia musica vuole infatti essere proprio questo: il racconto di un sogno, dove relitti di suoni e musiche di ogni epoca, geografia e natura interagiscono come eccentrici personaggi di un palcoscenico immaginario. Tale visione assai evocativa l’ho “tradotta” in un approccio compositivo che applico fin dall’inizio della mia avventura compositiva, e che ho battezzato “analisi e risintesi”, mutuando una terminologia e un processo tipico della musica elettronica sperimentale, “l’altra metà del cielo” creativo in cui opero.

Per “analisi” intendo, tra le altre cose, lo scandaglio di materiale musicale pre-esistente, tratto ad esempio dalla “tradizione dei suoni del passato” che lei citava nella domanda, ma l’esplorazione analitica può riguardare allo stesso modo realtà cronologicamente più vicine o contemporanee, quali la pop music o l’elettronica, sempre all’insegna della loro stratificazione e “coabitazione” in noi, frutto anche della facilità - di cui parlavo pocanzi - con cui il web permette oggi una fruizione quasi istantanea di “mondi lontani” nello spazio e nel tempo. Insomma, oggi possiamo viaggiare virtualmente alla velocità della luce e abbiamo anche una macchina del tempo, almeno verso il passato. Non che creativi di altre epoche non avessero la possibilità di attingere indietro nel tempo o (relativamente) lontano nello spazio: un tale Johann Sebastian Bach ha praticamente analizzato “passati” musicali che lo interessavano, mi riferisco a stili a lui precedenti o comunque già parzialmente - mi perdoni il gioco di parole - “passati di moda” ai suoi tempi, spesso espressione di realtà geografiche diverse dalla propria, seppur non lontanissime. Lo stesso Bach li ha poi ri-sintetizzati in qualcosa di nuovo, inudito e forsanche “inaudito”, la cui portata non sarà purtroppo colta dai suoi stessi coevi, ma questa è un’altra storia. E pensiamo anche a esperienze come l’impatto di Debussy col gamelan giavanese, per restare a casi eclatanti nella storia della musica occidentale.

Ciò che cambia oggi rispetto a ieri è la velocità, la rapidità di alternanza e - punto secondo me cruciale - il livello di immersività di queste esperienze musicali che si accavallano nell’era del web e della realtà virtuale, e che possono spesso sostituirsi al reale, pur mantenendo il loro potere di stratificazione e influenza sulla nostra creatività. Intendiamoci: Bach dovette fare quattrocento chilometri a piedi per ascoltare Buxtehude, mentre per Debussy è stato fondamentale l’hic et nunc di un expo universale per dare una svolta al suo stile. Oggi quante influenze dei compositori si giovano (anche) della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte, come modalità primaria di conoscenza? Ligeti nel 1982 fu colpito dalla sorprendente complessità della musica dei centrafricani Banda-Linda grazie a un disco - ecco la riproducibilità tecnica! - registrato da Simha Arom, portato alla sua attenzione da un suo studente di composizione, Roberto Sierra. Oggi avrebbe usato forse Google e YouTube, e magari in un’altra finestra del browser avrebbe ragionato su altre influenze musicali diametralmente opposte, passando rapidamente dall’una all’altra, chissà! Fantasie a parte, certamente la fruizione a seguito di riproduzione tecnica e virtuale dell’opera d’arte pone anche problemi e ha certamente risvolti potenzialmente negativi in certi casi: quanto perdiamo, ad esempio, in un ascolto riprodotto o nella virtualità rispetto all’esperienza reale, per alcune forme di creazione artistica, come un brano di classica o un quadro? Tanto, certamente. Per questo è importante esserne consapevoli. Ma c’è anche da dire che la stessa riproducibilità tecnica prima e il virtuale poi hanno creato nuove forme artistiche che mischiano questi piani o del tutto annullano il problema, sono cioè esse stesse “l’esperienza fruitiva”. Del resto è normale che l’avanzamento tecnologico crei nuove forme artistiche insieme con nuove modalità fruitive ma, almeno per quanto mi riguarda, agisce anche su ciò che chiamiamo “tradizione”. Il fatto cioè di avere tutto in un punto e in un istante genera una sensazione di “svecchiamento” della tradizione, specie se non consideriamo - io non lo faccio mai - quest’ultima solo come un passato da riesumare e da utilizzare come contrasto al “nuovo”. Al contrario, io cerco nella musica del passato elementi vitali, veri e propri “universali” che vadano oltre il tempo e le mode, che poi sono gli stessi elementi che rivivono e mi/ci emozionano quando tale musica è eseguita dal vivo ancora oggi. Alcuni di questi elementi possiedono di per sé un senso di estrema modernità, aprendo interessanti prospettive di dialogo con la contemporaneità. E comunque anche le tradizioni non sono organismi cristallizzati ed eternamente immutabili. Al contrario, vivono continuando a conformarsi e a modificarsi nel tempo, un po’ come fa, ad esempio, il linguaggio, alcune possono sembrare creature artificiali, e forse lo sono davvero! Tornando al mio metodo compositivo, cosa accada poi a tutti questi riferimenti analizzati ce lo dice la fase successiva, ossia la ri-sintesi, che è una combinazione ed elaborazione personale secondo uno stile e una logica propria degli elementi precedentemente analizzati. Il risultato finale non mira quindi a ricostruire passati posticci o a copiare - male! - mondi sonori geograficamente lontani, bensì a sperimentare nuovi rapporti possibili (e inusuali) tra processi, tecniche ed elementi processati.

Sovente, per spiegare la sua visione estetico/compositiva, prende a modello due grandi compositori contemporanei, Luciano Berio e György Ligeti. Che cosa rappresentano per lei e la loro musica come aderisce con la sua proiezione creativa?
In effetti il metodo di analisi e risintesi che ho appena descritto prende le mosse proprio da una considerazione - per me illuminante - di Luciano Berio, il quale sosteneva che il miglior modo per analizzare un brano fosse di scriverne un altro. Mi sento inoltre debitore di Berio per un altro grande insegnamento e stimolo creativo: mi riferisco al suo vigore intellettuale interdisciplinare, alla sua inimitabile maestria nel saper mettere in relazione la musica con vari campi del sapere umanistico (linguistica, poesia, antropologia…) spesso evidenziando genialmente la relatività di alcune distinzioni “convenzionali” tra essi. C’è poi una dimensione ulteriore nel mio rapporto con Berio, che intreccia il piano professionale a quello personale. Non ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, ma ho vissuto anni fa un’esperienza unica, che mi ha avvicinato alla sua figura sia artistica che umana in maniera indelebile. Possiamo dire che tutto nacque, neanche a farlo apposta, dalla “riproducibilità tecnica” di cui parlavo nella risposta precedente: una dozzina di anni fa fui scelto dal Centro Studi Luciano Berio di Firenze, istituzione fortemente voluta dalla vedova del compositore, Talia Pecker, e diretta all’epoca da Angela Ida De Benedictis, per identificare e catalogare l’archivio sonoro privato del compositore ligure, costituito da alcune centinaia di nastri magnetici conservati da Berio fin dagli anni Cinquanta. Vi si trovano, ad esempio, registrazioni di prove di brani beriani con musicisti (preziosissime perché in alcuni casi includono anche il talkback, ossia la voce di Berio proveniente dalla regia dello studio di registrazione nel quale si svolgevano le prove, ricca di osservazioni, commenti, suggerimenti interpretativi sui propri lavori). Ci sono anche bozze, materiali di lavoro o incisioni di lavori finiti, relativi alla produzione elettronica ed elettroacustica del compositore, così come registrazioni di esecuzioni dal vivo di brani strumentali e vocali, ma anche interviste, qualche “cartolina” audio (un messaggio vocale, diremmo oggi) ai parenti, persino registrazioni private di feste con familiari e amici. E c’è anche, e non poteva essere altrimenti con Berio, musica altrui di varia natura, inclusi esempi di culture musicali e paesaggi sonori relativi a folklori vicini (come i canti popolari italiani studiati dalla cantante ed etnomusicologa Sandra Mantovani) e lontani, ricchissimo serbatoio di spunti creativi musicali ed intellettuali. Ne esce un ritratto di Berio a tutto tondo, costruito peraltro proprio col suono, e che ha richiesto più di due anni per essere ri-tracciato attraverso ripetuti ascolti attenti, ricerche, ipotesi, confronti, quasi quotidiani, tanto che, per darmi la possibilità di concentrarmici maggiormente, la vedova Berio mi offrì di alloggiare nella casa fiorentina del compositore, a due passi dal Centro Tempo Reale dove lavoravo e dove i nastri erano custoditi. Mi sembrò incredibile poter vivere nel loft sede del primo studio di Berio appena giunse a Firenze, ancora in parte pieno di sue cose, foto, libri, la sua scrivania, alla quale lavoravo di notte - unico tempo che mi rimaneva - a nuovi miei pezzi. Davvero mancava solo la sua persona!

Ligeti invece lo “incrociai” (se così si può dire) fisicamente una volta, se non ricordo male nel maggio del 1996 all’Auditorium del Lingotto di Torino. I Berliner diretti da Abbado eseguivano una sinfonia di Mahler e il meraviglioso Lontano di Ligeti per grande orchestra, col compositore ungherese presente in sala. Io ero poco più di un ragazzo, fui “spedito” a quel concerto con un biglietto omaggio del Conservatorio. Non potevo ancora immaginare un futuro nella musica (tanto meno nella composizione) e - lo ammetto candidamente - non avevo la più pallida idea di chi fosse Ligeti! Col senno di poi, quanto avrei voluto almeno ringraziarlo di persona, per tutto quello che la sua musica ha rappresentato per me. Lo stesso titolo del mio nuovo album, Musica Ritrovata, è un palese omaggio alla ligetiana Musica Ricercata e al suo autore. Del resto, la capacità di far proprie le tracce delle idee di base di altre culture musicali, decontestualizzandole e sintetizzandole come concezioni personali in un processo compositivo, è massima in Ligeti, ed è stata anch’essa di grande ispirazione, insieme con la lezione di Berio, nel delineare il mio metodo compositivo.
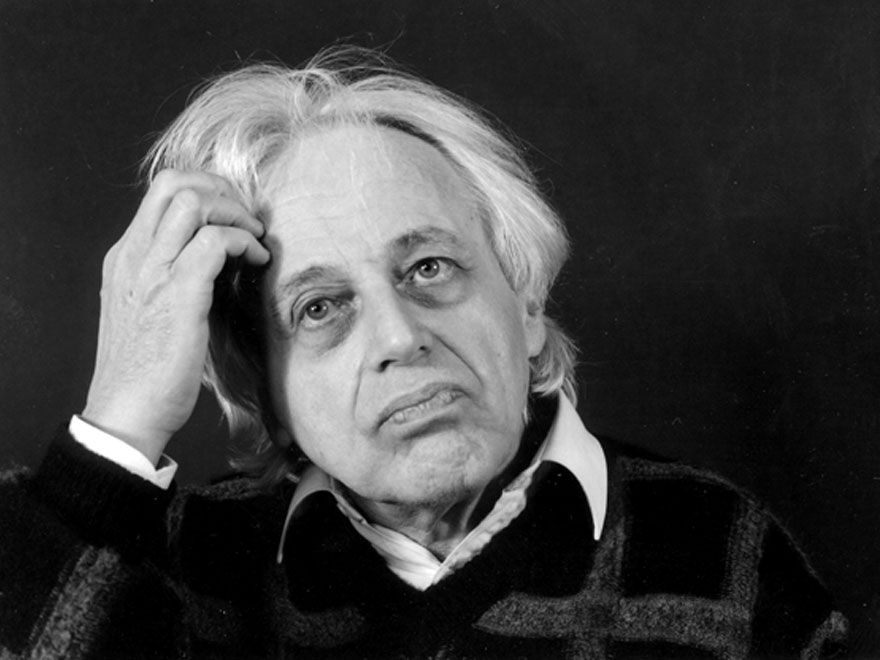
Oltre al mondo dei suoni, il suo processo artistico si basa anche su elementi extra-musicali, che siano letterari, cinematografici, mitologici. Come avviene, quindi, la trasmutazione di un segno visivo, lessicale, simbolico in quello musicale?
La fase di analisi del mio metodo può riguardare non solo suoni e musiche di altre ere e geografie, ma anche concetti e riferimenti extra-musicali di qualunque tipo, dalle altre arti alle scienze, al cinema. Partiamo proprio dal cinema per fare un esempio. Nel brano Shift per fisarmonica da concerto, presente nel mio nuovo album Musica Ritrovata grazie all’interpretazione di Ghenadie Rotari, ma anche nel disco Variazioni di Corrado Rojac, uscito nel 2010, vi sono ben due “antecedenti cinematografici” rispetto alle fonti del materiale processato. La trasmutazione in musica avviene su più livelli in questo caso. Si parte dal più semplice “furto” di estratti tematici, quindi non ancora una vera e propria trasmutazione, utilizzando ed elaborando variamente, anche ibridandoli tra loro, frammenti melodici dalla soundtrack di Limelight (Luci della ribalta) di Chaplin e da quella - opera di Nino Rota - del documentario televisivo I clowns di Fellini. Proprio tramite le tipologie di pagliacci della tradizione circense occidentale, il Bianco, mite e disciplinato, e l’Augusto, ribelle e imprevedibile, si giunge, a un livello più complesso, ad una trasmutazione non tanto dei materiali musicali quanto della modalità del loro sviluppo e processamento. Il modello, ripetuto su più scale temporali e ordini di grandezza, è quello di una struttura che tenta di costruirsi ordinatamente - mettiamo, per capirci, un tema che prende forma nota dopo nota - ma viene sempre interrotta da break improvvisi e imprevedibili colpi di scena, simboleggiando il copione tipico delle routine tra Bianco e Augusto.

Un ulteriore livello di trasmutazione (e di complessità) derivato dalle pellicole di Chaplin e Fellini è riferito, come ho scritto nelle note di sala del brano, «ai modi maggiore e minore, agli affetti a loro antropologicamente connessi, la gioia, il dolore… Penso ai clown, alla loro capacità di alternare o confondere questi stati d’animo fino a ribaltarne il senso, come avviene anche in musica. Penso al Chaplin violinista del finale di Luci della ribalta, terminare in lacrime il suo motivetto in maggiore». Ecco, mi interessava creare una sorta di corto circuito tra questi cliché percettivi (il maggiore allegro, il minore triste…) proprio riferendomi ad esempi che confondono questi piani. Del resto, lo studio op. 10 n. 3 di Chopin non è certo un esempio di maggiore “allegro”, ma un perfetto generatore di malinconia, così come nessun giovane patito di EDM, anche dopo abbondanti sovradosaggi di modo minore, esce da una discoteca in lacrime dalla tristezza. Fu Jean-Jacques Nattiez a raccontarci, durante una sua lezione, di esperimenti con un campione di ascoltatori cui veniva “somministrato” il celebre Molto Allegro dalla Sinfonia n. 40 in sol minore K550 di Mozart con interpretazioni e tempi di metronomo diversi; al termine di ciascun ascolto veniva chiesto al campione di descrivere con alcune parole le sensazioni ricevute dall’esecuzione, e i termini affini al concetto di “tristezza”, generalmente associati al modo minore, erano meno numerosi a seguito dell’ascolto dell’esempio con tactus più rapido. Ciò che mi interessava era collegare questi discorsi, scaturiti dai film, ad altri possibili punti di appiglio legati ai parametri musicali e anche, nello specifico, alla natura organologica dello strumento musicale per cui stavo scrivendo. Nella fisarmonica tradizionale i bassi standard non “sciolti” generano proprio triadi maggiori e minori (oltre ad altri tipi di accordi), e Shift nasce proprio, armonicamente parlando, come riflessione speculativa sulle strutture armoniche simmetriche generate dalla sovrapposizione di triadi maggiori e minori.
Quanto conta la voce, sia nella sua capacità evocativa, sia nella sua possibilità di trasmettere una forza semantica, nella sua musica? È tentato dal mondo operistico e, soprattutto, nel mondo che viviamo la musica teatrale ha ancora una sua ragione d’essere?
La ringrazio molto per questa domanda, poiché per me sia la semanticità (sia essa di derivazione vocale o meno) che il teatro e la drammaturgia sono aspetti fondamentali del mio pensiero creativo. Fin dall’inizio li ho intesi insieme, ma paradossalmente cercandoli e ricreandoli nelle composizioni anche in assenza dei loro principali vettori. Harpagonie, il brano del 2006 che per la prima volta mi fece pensare seriamente di intraprendere la carriera di compositore, dato il riscontro che, dopo il debutto alla Chigiana di Siena, ebbe assai rapidamente (soprattutto negli USA), fu inizialmente concepito con un organico strumentale nutrito, costruito attorno a una voce e a un testo, tratto dal celebre monologo di Arpagone ne L’avaro di Molière. Ebbene, uno dei miei maestri dell’epoca, Azio Corghi, mi consigliò via via di eliminare strumenti, fino al paradosso di dirmi di togliere persino la voce! Aveva ragione lui: restò null’altro che una tromba sola sul palcoscenico, che però, grazie a un uso innovativo delle sordine per creare una sensazione di polifonia virtuale, grazie a un mantenimento del profilo d’intonazione del testo recitato nel materiale melodico impiegato, unitamente a una gestualità meta-musicale, che prevedeva sguardi e movimenti particolari della campana, riuscì a dare il senso di una mise en scène teatrale drammaturgicamente pienamente “autosufficiente”, attiva sul piano sia uditivo che visivo, e soprattutto potenziata dalla loro interazione. Ancora una volta tornano utili le parole di Berio (dalle sue Lezioni americane): «Nell’ascolto di qualsiasi suono intenzionalmente musicale è insopprimibile la tendenza a cercare collegamenti con un’azione umana». Questo esito particolarmente felice (tempo dopo mi contattò uno studente di un’università americana per una lezione sull’interpretazione del brano; dapprima caddi, come si suol dire, dal pero, poi mi spiegò che un suo docente, a sua volta interprete del mio lavoro in un festival, aveva inserito il pezzo nei programmi di studio dell’ateneo per i trombettisti) mi spinse a una ricerca più marcata sulle possibilità anche drammaturgiche della scrittura per strumento solo, tanto che la mia produzione strumentale in tal senso è stata definita “un teatro di gesti sonori”, e io stesso ho parlato in diverse occasioni di “palcoscenico teatrale immaginario”.

La ricerca e l’esaltazione di una drammaturgia intrinseca alla musica strumentale non ha tuttavia cancellato dalla mia pratica compositiva l’uso - e l’importanza - della voce in generale, o la frequentazione col “vero” teatro musicale sperimentale. Penso alla vocalità (più tradizionale, ma intrecciata su trame timbriche contemporanee affidate a strumenti rinascimentali e barocchi) nell’atto unico Mandragola, in scena al Festival di Aix en Provence nel 2013, per la regia di Rares Zaharia. Mi viene anche in mente il fruttuoso sodalizio col geniale regista Giancarlo Cauteruccio, e in particolare due suoi esiti: C.A.N.T.O., del 2011, lavoro drammaturgico con un organico musicale formato esclusivamente da voci femminili ed elettronica, e Tre Movimenti di Luce, del 2015, “operarchitettura” per il 78° Maggio Musicale Fiorentino, scritta in occasione del 750° anniversario di nascita di Dante, dove un’unica voce femminile, quella di Chiara de Palo, incarnazione di Beatrice, funge da collante nel percorso (fisicamente intrapreso a piedi dal pubblico, dopo un prologo addirittura su un bus urbano) tra tre location diverse, tra sotterranei e cavea a cielo aperto sul tetto del nuovo Teatro dell’Opera di Firenze, che rappresentano rispettivamente Inferno, Purgatorio e Paradiso. In entrambi i lavori la voce spazia tra la trasmissione della sua forza semantica e l’essere materia sonora pura. A dire il vero questa dialettica tra essere vettore di significato e materialità pura, tra culturale e naturale, insomma, la considero possibile - e non a caso torniamo circolarmente all’inizio della mia risposta - anche nella musica strumentale, laddove si consideri la “pressione semantica” (citando una locuzione impiegata da Luca Francesconi) anche in termini di riconoscibilità e di significato acquisito di un certo materiale musicale all’interno di un determinato contesto culturale. E anche in questo caso sono le ambiguità, le posizioni intermedie, i corto-circuiti rispetto al prevedibile, come si diceva riguardo al brano per fisarmonica, a intrigarmi maggiormente.

Quali sono gli autori contemporanei, al di là di quelli già citati, che ammira maggiormente?
Osservando la tracklist del mio nuovo album Musica Ritrovata, dove ben due brani utilizzano nel titolo la parola-suffisso -Fragmente, e di fatto si presentano come microludi, è abbastanza evidente l’influenza di György Kurtág, altra mia “passione”. Devo ringraziare Fabio Vacchi, uno dei miei maestri “storici”, che mi fece conoscere i Kafka-Fragmente alla mia prima lezione con lui, prima ancora di parlarmi, come forse altri avrebbero fatto, della propria musica. Ammiro la musica dei miei maestri che ho pocanzi definito “storici”, quelli coi quali mi sono perfezionato per diversi anni dopo il Conservatorio, diplomandomi presso le maggiori accademie italiane. Oltre a Fabio Vacchi, sotto la cui guida ho conseguito tra l’altro un master in composizione teatrale e coreutica all’Opera Academy dell’Arena di Verona, ci sono Alberto Colla (Perosi di Biella), Azio Corghi (Santa Cecilia di Roma e Accademia Filarmonica di Bologna) e Ivan Fedele, col quale ho studiato all’Accademia Pescarese e poi diplomato all’Accademia di Santa Cecilia di Roma. Ciascuno mi ha lasciato qualcosa non solo didatticamente, ma anche e soprattutto attraverso la propria musica. Stesso discorso vale per molti dei compositori (davvero assai diversi come figure e profili artistici e creativi) con cui mi sono perfezionato anche in più occasioni, ma per un tempo più limitato rispetto ai maestri “storici” suddetti: Luca Francesconi, Peter Eötvös, Luis de Pablo, Peter Maxwell Davies, Yan Maresz, Mauro Lanza, Alvin Curran, senza dimenticare Kaija Saariaho. Quest’ultima ha una posizione privilegiata nel mio olimpo personale di “divinità” compositive: amo la sua musica quasi “sinestesica”, raffinato insieme di fragranze, sfumature di colore e luce, di presenza e lontananza. La conobbi nel 2009, al festival Urticanti di Bari, sentì alcuni miei brani che apprezzò molto. Un paio di mesi dopo venni contattato dall’Ensemble InterContemporain, ovviamente - ero più giovane e un po’ sprovveduto - pensai ad uno scherzo, trattandosi di una delle maggiori compagini della scena contemporanea. Invece era tutto vero, Kaija li aveva indirizzati a me, raccomandando la mia musica, ma senza dirmi nulla!

A che cosa sta lavorando attualmente, e in un prossimo futuro ha già in cantiere una nuova produzione discografica?
In questi primi mesi del 2022 sto lavorando principalmente a… “recuperare” più tempo ed energie da dedicare alla mia famiglia, che alla fine del 2021 si è ulteriormente allargata con l’arrivo di un secondogenito. Tiro anche il fiato dopo un anno difficile per motivi personali e che, professionalmente, ha visto la conclusione, non senza sforzi e difficoltà varie, di due grandi e impegnativi progetti: il nuovo album Musica Ritrovata da un lato, e un ambizioso - se vogliamo folle - progetto di trascrizione per due pianoforti senza voci del primo atto di Turandot, a cent’anni dalla stesura originale di Puccini. Operazione estrema ma piaciuta all’editore storico pucciniano, Casa Ricordi, che l’ha appoggiata e - caso raro - autorizzata, e di cui dallo scorso 22 dicembre, giorno del compleanno di Puccini, è partita una tournée che continuerà quest’anno, col duo pianistico Barboro-Proietti, committente del lavoro. A dire il vero, nonostante l’incremento di ninne nanna e pannolini, non mi sono mai del tutto fermato: in queste settimane sto infatti lavorando a progetti di installazioni sonore e a nuovi brani con elettronica, e ho ripreso - la sua domanda cade quindi a fagiolo - anche a lavorare a un nuovo progetto discografico, già imbastito per circa un 30-40 per cento, che riunirà brani vecchi e nuovi attorno al concetto di gesto, gestualità, azione legata all’immaginazione sonora. È una riflessione già presente in Musica Ritrovata e nella mia musica in generale (l’abbiamo toccata anche nelle risposte precedenti, parlando di Harpagonie per tromba sola), ma in questo caso sarà centrale e rappresenterà il focus attorno al quale l’album sarà costruito. Mi piacciono le produzioni discografiche con una forte idea alla base; non solo una compilation di brani, ma un pensiero che li leghi.
Andrea Bedetti

