Credo che non possa essere bollata a livello di eresia l’affermazione che Ferruccio Busoni faccia ancora fatica ad essere accettato come uno dei maggiori compositori a cavallo tra Ottocento e Novecento e che tale difficoltà risieda soprattutto nel fatto che il musicista empolese nel corso della sua vita sia stato contemporaneamente più cose; virtuoso del pianoforte, prima di tutto, didatta di razza a partire dai ventitré anni d’età in quel di Helsinki, per poi insegnare a Weimar, Vienna, Basilea e Boston, intellettuale e saggista di vasti interessi interdisciplinari (le sue amicizie e una lettura attenta della sua corrispondenza lo testimoniano esemplarmente) e, visto dal distorto e meschino punto di vista di un italico provincialismo, il disagio di avere a che fare con un artista che, nato italiano, si sentì proiettato a attratto sempre più dall’incommensurabile arcipelago musicale di ambito germanico (un destino, questo, che lo accomuna con un altro grande del panorama nostrano, quell’Ermanno Wolf-Ferrari la cui vita e la cui opera si svolsero sui due piatti della bilancia italo-austriaca, pendendo ora più su uno, ora più sull’altro).

Ma pochi, pochissimi hanno saputo cavalcare la tigre della Krisis artistico-culturale nel Vecchio continente, se per Krisis s’intende quel polimorfico tentativo di dare vita a novelle istanze, capaci di mutare in una radura assolata, pregna di sviluppi e feconde argomentazioni, oppure in un binario morto avvolto desolatamente dalla sterpaglia, come seppe fare Busoni con la sua opera compositiva. La quale, a ben vedere, resta tuttora confinata tra cultori, musicofili, addetti ai lavori, mentre tende tuttora a lambire, sulla battigia del presente, i piedi e le caviglie del grande pubblico, divoratore bulimico e compulsivo dei soliti nomi del panorama musicale.
Quindi, è da considerare con soddisfazione ogni progetto discografico che viene fatto per offrire all’ascolto, si spera sempre più di molti, pagine della produzione del compositore empolese, come quella, recentissima, fatta dalla Da Vinci Classics, che ha fissato su disco un interessantissimo concerto effettuato dal pianista romano Giovanni Bellucci il 13 e il 14 giugno 2002 all’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto di Torino, registrato in quell’occasione dalla RAI, con il direttore Daniele Callegari alla testa dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, incentrato su pagine concertistiche poco conosciute (almeno per il vulgo) di Ferruccio Busoni, per la precisione l’arrangiamento per pianoforte e orchestra fatto dallo stesso musicista empolese della Rhapsodie Espagnole S. 254/R90 Folies d’Espagne et Jota Aragonesa di Franz Liszt, del Concertino BV 292 per pianoforte e orchestra, e dell’Indianische Fantasie op. 44 per pianoforte e orchestra BV 264. A impreziosire questa produzione, la quale rappresenta per l’etichetta di Edmondo Filippini una pietra miliare, visto che con questo CD raggiunge i mille titoli di catalogo, augurandogli di cuore che non valga per la sua label la nefasta profezia attribuita apocrificamente al Cristo del «mille e non più mille», si aggiungono anche le note di accompagnamento stilate all’epoca da Piero Rattalino, che il critico e didatta piemontese vergò appositamente per Bellucci nel dicembre del 2004 per un suo disco, ma rimaste fino ad ora inedite.

Abbinare il nome di Busoni alla sua produzione concertistica per pianoforte e orchestra porta immediatamente a pensare quella che resta una delle composizioni più originali e particolari di tutto il tardoromanticismo europeo, ossia il suo ipertrofico, monumentale, polimorfico Concerto in do maggiore op. XXXIX, KV 247, che prevede la presenza anche di un coro maschile che canta un testo del poeta danese Adam Oehlenschläger. Opera pochissimo eseguita, questa, così come pochissime sono inevitabilmente le sue registrazioni discografiche (i motivi sono stati spiegati assai bene da Sergio Sablich, sulla base del fatto che siamo abituati ad ascoltare e ad assimilare tramite rigidi schemi precostituiti, i quali, però, non possono essere applicati su una personalità artistica così libera come quella incarnata da Ferruccio Busoni). A livello di esecuzione e di incisione, i lavori che Giovanni Bellucci ha voluto presentare in questo concerto torinese non è che se la cavino meglio, in quanto anch’essi hanno sempre avuto una veicolazione di ascolto marginale. Quindi, la volontà del pianista romano di offrire in sede concertistica un concentrato così alto di pagine busoniane è assolutamente da rimarcare.
Entrando nello specifico e seguendo l’ordine della tracklist, non stupisce che un lisztiano di razza qual è Giovanni Bellucci abbia voluto inserire nel suo programma questo arrangiamento del compositore empolese su un brano del collega magiaro; Busoni conosceva a menadito non solo la produzione tastieristica del Kantor, ma anche quella di Liszt, punto di riferimento ineludibile dell’universo pianistico del secondo Ottocento. È interessante notare come Busoni abbia scelto per una sua trascrizione di Liszt (tra l’altro, esiste anche quella per due pianoforti) un brano non certo tra i più conosciuti, la Rhapsodie Espagnole, che fu scritta dal genio di Raiding verosimilmente intorno al 1863 per solo pianoforte. Più di trent’anni dopo, esattamente nel 1894, il giovane Busoni decise di farne una trascrizione, ampliandola al genere del concerto per pianoforte e orchestra. Oddio, parlare di una vera e propria “trascrizione” potrebbe apparire una forzatura, se si tiene conto di come il musicista empolese rispettò la partitura originale, con lo scopo principale di assecondare non solo l’abilità tecnica e il virtuosismo pirotecnico del brano, ma soprattutto evidenziando le tipiche caratteristiche timbriche lisztiane, permettendo così di esaltarle tramite lo sfruttamento delle sezioni orchestrali, le quali sono ben agguerrite grazie a un ottavino, tre flauti, due oboi, due clarinetti, due fagotti, quattro corni, due trombe, tre tromboni, tuba, triangolo, castagnette, tamburello, piatti e archi. Con una tale strumentazione, Busoni andò a nozze, potenziando il susseguirsi di danze che infarciscono i due episodi distinti, ma non indipendenti, denominati rispettivamente Follie di Spagna e Jota aragonese.
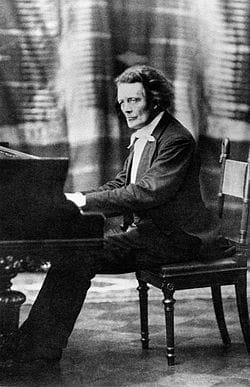
La vicenda legata al Concertino BV 292 merita di essere raccontata per comprendere meglio le sue peculiarità, visto che è composto da due diversi brani, il Konzertstück op. 31a, risalente al 1890, e Romanza e Scherzoso op. 54, scritto ben trentun anni dopo. Cominciamo dal primo, che fu composto da Busoni, all’epoca ancora oscuro docente al conservatorio di Helsinki, per prendere parte a quello che può essere considerato il primo, vero concorso internazionale di composizione ed esecuzione pianistica, ideato e portato avanti da uno dei più celebri virtuosi dell’epoca, il russo Anton Rubinštejn. Per l’occasione, Busoni creò il Konzertstück, che fu da lui eseguito, all’interno del concorso in questione, il 27 agosto a San Pietroburgo sotto la bacchetta di Moritz Köhler, aggiudicandosi così il primo premio. Sia ben chiaro, con il senno del poi non ci troviamo di fronte a un capolavoro e se Busoni si aggiudicò il primo premio è soprattutto per il fatto che al concorso san pietroburghese, riservato a giovani tra i venti e i ventisei anni, non presero parte né compositori affermati, né vennero presentati concerti di una certa levatura capaci di contrastare quello dell’empolese. Inoltre, anche se non volle “ungere” debitamente Rubinštejn e il suo giudizio, così come quello della giuria, è altrettanto vero però che il Konzertstück rappresenta un brano “composto su misura”, ossia capace di solleticare il grande virtuoso russo per via di un virtuosismo trascendentale, figlio di quello lisztiano sul quale il giovane Busoni stava appuntando tutta la sua attenzione in quel periodo, e impregnato di una monumentalità che sfiora la retorica, se ascoltato oggi, ma che risultò perfettamente in linea con il de gustibus del tempo. D’altronde, è sufficiente ascoltare l’Allegro, che segue l’Introduzione lenta, per rendersi conto di ciò, soprattutto quando si giunge alla cadenza, che si trasforma nella scrittura busoniana in un fugato dalle dimensioni elefantiache.
Ora, il Busoni di trent’anni dopo, che padroneggiava ormai la materia sonora come un dio in terra, si rese perfettamente conto di quel “peccato di gioventù”, e per sistemare il tutto, senza dover per forza rinnegare e cestinare quel lavoro che, tra l’altro, era stato stampato nel 1892 da Breitkopf & Härtel a Lipsia, decise di far quadrare il cerchio aggiungendo una seconda parte, rappresentata per l’appunto da Romanza e Scherzoso, dedicandola a un altro grande pianista e geniale compositore nostrano, Alfredo Casella, con il quale aveva già da tempo stretto un legame di amicizia. Con questa sorta di addendum, il compositore empolese intitolò questa “nuova” pagina double-face Concertino, come viene oggigiorno presentato ed eseguito, la quale, però, inevitabilmente soffre di questo impianto eterogeneo.

La Indianische Fantasie, op. 44, composta tra il 1913 e il 1914, rappresenta un tipico esempio di quella “libertà” evocata da Sergio Sablich e che sta alla base della sensibilità estetica, prima ancora di quella musicale, di Ferruccio Busoni. Libertà come sinonimo di inesauribile curiosità e apertura a stili non riconducibili alla tradizione rigorosamente occidentale. In questo caso, il punto di partenza è dato dalle due tournées americane che il musicista empolese fece nel 1910 e 1911, che rinforzarono, anche dall’altra parte dell’oceano, la sua statura di assoluto virtuoso del pianoforte (quindi, ancora una volta, la sua immagine di interprete, più che di compositore). In quelle due occasioni, però, il Busoni-creatore ebbe la possibilità, grazie a una sua ex-allieva newyorkese, Natalie Curtis, di conoscere, restando folgorato, numerose melodie originali della musica degli indiani pellirosse da lei raccolte e catalogate. Entusiasmato da quella scoperta, Busoni in un primo momento pensò di impiegarle per dare vita a una pagina per pianoforte e orchestra, intitolata Rapsodia indiana (sic). Però, tutto il progetto fu da lui riconsiderato una volta tornato in Europa, con il risultato finale fissato per l’appunto nella cosiddetta Indianische Fantasie, la quale fu eseguita per la prima volta a Berlino nel 1914 sotto la direzione di Alexis Birnbaum e con lo stesso autore al pianoforte. Il suo successo e la sua fama resistettero finché a interpretarla fu Busoni, poiché dopo la sua morte cadde progressivamente nel mare magnum dell’oblio, come diverse altre opere dell’empolese.

Emblematicamente, questa Fantasia, articolata nei tempi Fantasy, Canzona e Finale, si apre e si chiude sulla tonalità del do maggiore, il che già ci fa capire la ventata di speranza e di ottimismo con la quale Busoni auspicava una concezione di “musica universale” incarnata anche da questa composizione; la pentola compositiva presenta al suo interno un bel mix di ingredienti mediati da un festival timbrico quantomai variegato e affascinante, del quale è protagonista assoluto il pianoforte, forte e prepotente della sua investitura contrappuntistica. Proprio quest’ultima fa da scheletro all’immancabile portata formale, tipica in Busoni, che irregimenta il continuo fluire dei passaggi e del dialogo tra strumento solista e accompagnamento orchestrale.
Di fronte a un siffatto programma, va subito detto che un interprete che abbia una piena dimestichezza con il pianismo e con il repertorio lisztiano parte enormemente avvantaggiato, cosa che con un paladino di Liszt qual è Giovanni Bellucci appare oltremodo lampante. A parte la Rhapsodie Espagnole, nella quale il pianista romano si muove come nel salotto di casa, manifestando quell’inconfondibile cesellamento del timbro, ora cristallino, ora possente, tipico dell’orchestra-racchiusa-nella-tastiera intesa da Liszt, che fa da appetizer a tutto il pasto-programma, la lettura che Bellucci propone delle altre due pagine busoniane non cade nella trappola di uno “scimmiottare” la visione del compositore ungherese, ossia tramutando l’empolese in un malcapitato nipotino del collega di Raiding. Lo testimonia il severo compasso, ancora acerbo nel compositore italiano, che il nostro interprete manifesta nell’incipit nel Konzertstück, nel quale il sapore agrodolce della temperie tardoromantica già incalza inesorabilmente. Insomma, va bene l’immagine, in quel preciso momento, di un Liszt-faro, ma tutto ha un limite e, come d’altra parte lo fece intravvedere Busoni, Bellucci lo rimarca di più, calibrando la ridondanza con pennellate di severità e di ordine delle cose di chiaro rimando all’altro nume tutelate dell’empolese, ossia il Kantor. In ciò viene aiutato dalla misurata partecipazione tra i chiari e gli oscuri proiettati dall’orchestra, che permettono a Bellucci di districarsi nella pastoia tra ciò che è costruzione e ciò che è virtuosismo tout court.

Con l’approccio a Romanza e Scherzoso, Bellucci/Dante fa ciao ciao con la manina a Liszt/Virgilio, si rimbocca le maniche, prende con le pinze Busoni e lo seziona pezzo per pezzo, con le pietanze del pasto che diventano decisamente assai più saporite. Nuotando in un mare orchestrale limaccioso, unto e malsano (ottimo punto di partenza), il pianista romano non esita a fornire un resoconto sonoro in cui la beata inquietudine dell’ultimo empolese sgorga liberamente. Il timbro è giustamente rappreso, perfino quasi esitante, per poi “illuminarsi” sebbene le ombre dell’accompagnamento strumentale non virino al tempo stabile di una giornata di sole. Con l’irruzione dello Scherzoso Bellucci ci spiega che in fondo Busoni, come Zarathustra, sapeva anche danzare; la sua è una danza che non cede mai all’eccesso (Ordnung… Ordnung…), ma è sapientemente disciplinata, canonica, giocata su un timbro che accarezza, che ci fa capire come Busoni abbia, in quell’ultimo periodo della sua vita, confidato in una speranza di assoluto, di totalizzante proiettato dal mistero sonoro. Luce come equilibrio, irradiazione come balsamo, tastiera come una Lamia in agguato.
Da ultimo, il Busoni etnoantropologo sonoro della Indianische Fantasie; qui, Bellucci ha agio nell’innestare la quinta marcia autostradale, trasforma la tastiera dello strumento in una Tesla a guida automatica e si gode il panorama offerto dalla partitura dell’empolese, nel senso che il suo incedere è disarmante nella proiezione agogica del brano, una risonanza magnetica che va a esplorare ogni minima sfumatura che si annida nella lussureggiante giungla che Busoni estrae dal caleidoscopio delle melodie messegli sotto il naso dalla Curtis. È come se un dipinto di Rousseau il Doganiere prendesse improvvisamente vita, complici anche le liane che le sezioni orchestrali gettano al solista, capace di afferrarle una ad una e tramutandole in materia pulsante. Ma non pensate che il tutto si tramuti in una prova di machismo, della serie “Io Tarzan, tu Jane”, perché Bellucci diluisce il tutto con un miracolo di liquidità, di cristallinità timbrica che letteralmente si scioglie in un ruscello sonoro (la Canzona!) e che ci ricorda come Busoni fosse un maestro del “ripiegamento”, di un dolcissimo rapprendersi inspirativo/espirativo, di un colore pianistico che andava a nozze con quello orchestrale (chi conosce il suo Doktor Faustus comprende a cosa mi riferisco); insomma, il Busoni che si entusiasma, baciato dalla potenza ristoratrice del venire-a-sapere-che-esiste-altro e che irrompe nel miracoloso passaggio dalla Canzona al Finale, allorquando si rompono le acque e il loro fluire non è come il catastrofico Vajont, ma lo specchio d’acqua nel quale Amfortas trova un momentaneo conforto nell’abbandonarsi alle sue abluzioni.
Un dovuto ringraziamento dev’essere concesso a Daniele Callegari che ha saputo imprimere alla resa orchestrale una marcia deliziosa e implacabile, quel dovuto elettrochoc da trasmettere alla materia applicata poi sulla tastiera, senza contare che i momenti unicamente orchestrali sono stati scolpiti con una carica febbrile che, spiace scriverlo, non soventemente si può riscontrare in una compagine nostrana. Sarà stato l’unicum della serata, sarà stato lo sguardo benevolo di Santa Cecilia, ma chi è stato presente a quell’evento/rito dovrà ritenersi fortunato e unto per il resto della sua esperienza di spettatore e appassionato.

L’unica nota leggermente stonata, almeno di fronte al gigantismo artistico della registrazione, è data dalla presa del suono e di cui non viene riportato il nome dell’artefice nelle note di accompagnamento al CD. Non so nemmeno se tale presa sia stata effettuata al pensiero che poi si sarebbe tramutata in una produzione discografica o limitata alla semplice trasmissione televisiva a cura della RAI. La dinamica, purtroppo, non è generata da una centrale nucleare e appare un po’ svilita e bisognosa di potassio e magnesio in dosi considerevoli, così come la velocità dei transienti, scialba, che si avverte soprattutto nei passaggi orchestrali. La ricostruzione del palcoscenico sonoro pone poi altri problemi, con una netta distanza che si avverte tra orchestra (posta in profondità) e il pianoforte (troppo ravvicinato) creando di conseguenza un “vuoto spaziale” tra l’una e l’altro e con un suono che non si estende in altezza e in ampiezza al di là dei diffusori. Il parametro dell’equilibrio tonale va un po’ meglio, con una maggiore precisione presentata dal registro medio-grave e quello acuto del pianoforte, in quanto i registri delle sezioni orchestrali (e questo vale soprattutto per i legni e per gli ottoni) risultano essere leggermente sfuocati. Infine, il dettaglio, che risente della carenza vitaminica della dinamica, presenta una evidente mancanza di matericità nello strumento solista e una piattezza che va a investire la proiezione tridimensionale della compagine orchestrale.
Andrea Bedetti
Ferruccio Busoni – Works for Piano and Orchestra
Giovanni Bellucci (pianoforte) - Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI - Daniele Callegari (direttore)
CD Da Vinci Classics C01000
Giudizio artistico 5/5
Giudizio tecnico 3,5/5




