Il mondo degli interpreti musicali si divide grossomodo in due categorie, coloro che esigono che il pubblico vada verso di loro e quelli che invece desiderano andare tra il pubblico, con i primi che obbligano per dare e i secondi che si sentono appagati nel dare. Tra questi ultimi un posto di prima fila lo ha sicuramente la compositrice e pianista romana Alessandra Celletti che nel tempo si è costruita l’immagine di artista “controcorrente”, alternativa a un certo cliché, refrattaria a indesiderati comportamenti divistici, avulsa da quel desiderio, per non definirla necessità, di creare una patina di distanza tra sé e coloro che ascoltano le sue esecuzioni.
Per avere un’idea non solo chi sia, ma anche come sia Alessandra Celletti invito a vedere il bellissimo documentario che il regista Marco Carlucci ha dedicato alla tournée che la pianista romana ha effettuato in diverse località italiane nell’estate del 2013, chiamata “Piano piano on the road” (lo si può vedere su YouTube), viaggiando a bordo di un grosso furgone che alla bisogna poteva aprire i tre lati e sollevare il tetto, trasformandosi così in un palcoscenico occasionale sul quale era fissato il pianoforte a mezza coda con il quale l’artista si è esibita in decine di piazze e strade di piccoli borghi oppure in luoghi naturali incontaminati, contando sulla presenza fedele di poche decine di ascoltatori.
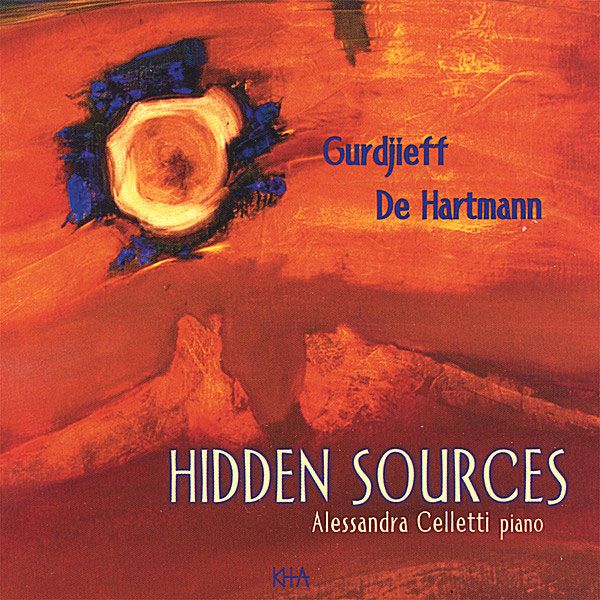
Per fare ciò, e il documentario in questione lo dimostra in modo esemplare, bisogna avere un animo fanciullesco, restare candidi come il fanciullino pascoliano o l’omonimo protagonista del romanzo voltairiano, non indossando mai i panni dell’istrione e pensando la musica sempre con il sorriso che allieta le labbra. Magari qualcuno potrà anche ironizzare guardando Alessandra Celletti esibirsi alla tastiera indossando buffi e particolari copricapi, come già fecero a loro tempo Friedrich Gulda e Sun Ra, o per il fatto che nel corso dei suoi concerti porti con sé degli oggetti a cui tiene in modo particolare (nel documentario si vede un’automobilina da lei modificata aggiungendo delle stelline argentate e un cuoricino di stoffa che esce dal tubo di scappamento, trasformato in un salvadanaio dove mettere i soldi guadagnati vendendo i suoi CD nel corso della tournée), retaggio forse di un modo di rappresentare la musica in altro modo, come lo fece a suo tempo John Cage con i suoi strumenti-giocattolo e le inseparabili paperelle con i quali divertiva il pubblico (a Mike Bongiorno non sembrò vero di ricamarci sopra, quando il compositore statunitense si presentò come esperto micologo nel corso di cinque puntate di “Lascia o raddoppia” nell’inverno del 1959).
Questo candore, questo modo di far trasparire la trasparenza del suo sentire musicale, Alessandra Celletti lo dimostra come interprete (in qualità di compositrice la pianista romana si pone su una discriminante nella quale confluiscono radici new age con sviluppi sottilmente minimalistici) attraverso un repertorio che partendo dalle musiche del canonico trittico francese formato da Satie, Debussy e Ravel, passa attraverso Leoš Janáček, per poi approdare nel corso del tempo ad autori come Gurdjieff/De Hartmann, Scott Joplin e Philip Glass, vale a dire musicisti potentemente intrisi di un’immaginifica energia espositiva “a presa rapida” e simbiotici alla sua linea di creazione pianistica. E questa linea privilegiata di autori da interpretare è presto spiegata: Alessandra Celletti per eseguire deve vivere la musica che intende esprimere, la deve sentire scorrere nelle vene, la deve respirare attraverso i pori dell’epidermide. L’intellettualità dev’essere sostituita in lei da un processo di suprema spontaneità, quella capace di farla sentire in sintonia con la propria essenza, quella che la spinge ad andare verso l’ascoltatore, anche da un punto di vista fisico, oserei dire epidermico con gli altri. È come se Alice, spinta da un invisibile Cappellaio Matto, scoprisse di essere felice solo quando raggiunge la dimensione di un suono da elargire intorno a sé.

Tale felicità di irradiazione la pianista romana la manifesta compiutamente in due registrazioni che appartengono alla primigenia produzione della casa discografica KHA, visto che non sono recentissime, vale a dire Hidden Sources, il primo disco da lei dedicato alla coppia Georges Ivanovič Gurdjieff e Thomas De Hartmann, risalente al 1998, e Metamorphosis di Philip Glass che, oltre ai cinque omonimi pezzi scritti per una rappresentazione teatrale della Metamorfosi di Franz Kafka, presenta due brani da The Hours (The Poet Acts e Dead Things) e altri due pezzi, Opening (tratto da Glassworks) e Modern Love Waltz, in un’incisione effettuata del 2004. Due dischi che ci fanno comprendere meglio il mondo della riproduzione mistico/sonora di Alessandra Celletti, in cui affiora un altro elemento cardine del tutto ineludibile, quello che riguarda il concetto idiomatico della danza, il quale evidenzia un bisogno, impellente nel pianismo di questa interprete, la cui manifestazione gestuale si accompagna sempre da invisibili passi di danza immanenti, poiché il suo modo di esprimere il suono è quello di portarlo ad affiorare da quelle profondità nel quale ristagna. Da qui la scelta di autori, come nel caso di Glass e della coppia Gurdjieff/De Hartmann, in cui il suono si accompagna alla necessità di esprimere “altro”. Se così nel compositore americano il minimalismo è spesso al servizio di “altre” forme artistiche, squisitamente visive come il cinema o il teatro, nell’iniziato armeno e nel musicista/allievo russo il connotato mistico che intride le loro musiche rimanda ad “altre” dimensioni spirituali che il suono espresso ne rappresenta una delle possibili realizzazioni fisiche. In entrambi i casi, Alessandra Celletti affida a una danza interiore quella capacità di saper esplorare il ritmo immanente che edifica i brani da lei scelti.

E se per ciò che riguarda Glass la linea di manifestazione può risultare più immediata, più lampante nel suo affiorare (l’apparente “semplicità” delle sue composizioni in realtà è il processo di una geniale scomposizione del suono che rimanda, a livello pittorico, a quella dei volumi esplicata dal cubismo), ciò è meno appariscente nelle composizioni che De Hartmann ha tratto a livello “occidentale” per ciò che concerne le ricerche etnomusicologiche che Gurdjieff fece tra il 1885 e il 1907 nel corso dii viaggi nelle zone più remote dell’Asia, della Russia e delle terre arabe alla ricerca di “quel lavoro su di sé” (in Francia, pochi decenni dopo, lo stesso fece in modo altrettanto mirabile un visionario come René Daumal attraverso la forza semantica della parola), ossia lo studio di una “quarta via”, come la definì il suo seguace più famoso, Pëtr Dem’janovič Uspenskij, quella capace di permettere all’uomo occidentale di mediare/metabolizzare il modus essendi appartenente all’impenetrabile mondo della sapienza orientale.

Anche Alessandra Celletti, Alice-nel-paese-della-musica, attraverso il suo pianismo, cerca di arrivare a una “quarta via”, dispensando e irradiando “quel lavoro su di sé” fatto di una danza espressiva che anima (in effetti, il suo è un timbro “animistico”) i diciotto brevi brani che fanno parte di Hidden Sources, con i quali De Hartmann ha fissato armonicamente le melodie che Gurdjieff ha attinto dalle tradizioni sapienziali asiatiche, dalla tradizione semantica che ammanta il lemma arabo sayyd, dietro il quale si cela il ruolo del “maestro”, di colui-che-indica, con le sue diramazioni della cultura turca, persiana, bengalese e urdu, dai ritmi esistenziali curdi e indù, socchiudendo una porta con la speranza che “altri” potessero infine aprirla (un tentativo, questo, che spiega la volontà dell’iniziato armeno di dare vita al priorato di Fontainebleau, nei pressi di Parigi, nel 1922). Ecco, ascoltando questo CD, la chiave di volta della sua assimilazione sta proprio nella capacità da parte della pianista romana di decodificarne l’arcano presente nei brani scelti attraverso questa espressione danzante (la danza rituale espressa con precise movenze è alla base dell’insegnamento del pensiero di Gurdjieff) e la sua comprensione risiede nel saper entrare nella sua dimensione danzante; se non si fa ciò, i diciotto pezzi che ne fanno parte non sono altro che motivi puramente melodici, alla fine perfino un po’ stucchevoli, tendenti a una falsa, reiterante ripetitività.

Anche la musica pianistica di Philip Glass presuppone la necessaria presenza di una volontà danzante, che sappia gestire le microscopiche variazioni di ritmo che sue composizioni impongono, altrimenti i presupposti della musica minimalistica rischiano di scadere ai livelli di una musica minima, insignificante. E in ciò Alessandra Celletti è assai convincente, soprattutto nel dosare l’intervento del registro basso (si ascolti, a tale proposito, la resa nel ciclo delle cinque Metamorphosis), il quale assume il ruolo concettuale dello svolgersi temporale, di una ineluttabilità che non può lasciare margini di intervento, di cambiamento in ciò che è già segnato e destinato ad essere. Per questo tendo ad associare la musica di Philip Glass alle tematiche filosofiche ed esistenzialiste di Albert Camus, e ciò nella conformazione ciclica delle Metamorphosis si realizza nella raffigurazione di un Sisifo che cerca di ribellarsi inanemente a ciò che è fissato, scolpito implacabilmente, immutabile nella sua proiezione temporale e spaziale. In più, o forse proprio per questo, nella lettura della pianista e compositrice romana si avverte anche un velo, una patina di soffusa malinconia, evidenziata da un timbro che sfuma in rotondità che ne ammorbidiscono la ferrea logica armonica, la sua matematica sonora. Non ho mai nascosto la mia predilezione verso quei compositori e interpreti che, musicalmente, sanno voltarsi, guardando dietro di loro, volgendo lo sguardo a ciò che è stato, più che a quelli che intendono solo guardare in avanti senza considerare o prendere in considerazione ciò che è già avvenuto e si è concretizzato. E da come Alessandra Celletti affronta il repertorio pianistico del compositore statunitense si riesce a percepire questo sguardo, questo fissare malinconico, dolcemente triste dello scorrere temporale, cosa non facile da far trasparire in una musica, come quella minimalista, in cui la scansione, la precisione del suo manifestarsi riducono inevitabilmente i margini di un “arricchimento” interpretativo, da intendere non come pleonastica “aggiunta, ma come “profondità” espressiva.

Trovo che la presa del suono sia migliore nella registrazione dedicata a Glass piuttosto che in quella consacrata alle pagine di Gurdjieff/De Hartmann, poiché in quest’ultima il pianoforte, soprattutto nel registro acuto e medio-acuto, fa trasparire una leggera, fastidiosa connotazione “metallica” e non credo che la volontà dell’interprete e di chi ha curato la cattura, Massimiliano Nevi, sia stata quella di dare un’impronta quasi “clavicembalistica” del suono. Cosa che invece non avviene nel CD glassiano, in cui Fabio Ferri, tramite una migliore dinamica in fatto di energia e velocità dei transienti, riesce a ricostruire con maggiore efficacia la fisicità dello strumento nel palcoscenico sonoro, ottenendo un equilibrio tonale tra i registri più omogeneo e non “slabbrato” e con un dettaglio decisamente più materico.
Andrea Bedetti
Georges Ivanovič Gurdjieff & Thomas De Hartmann – Hidden Sources
Alessandra Celletti (pianoforte)
CD KHA Records 001
Giudizio artistico 4/5 Philip Glass – Metamorphosis Alessandra Celletti (pianoforte) CD KHA Records 005 Giudizio artistico 4/5
Giudizio tecnico 3,5/5
Giudizio tecnico 4/5

