La musica del compositore milanese Davide Anzaghi, uno dei numi tutelari della musica contemporanea non solo italiana, ha il merito di mettere comprensibilmente a disagio l’ascoltatore, che egli sia attivo o passivo nell’ascolto stesso. E se ciò può essere pienamente plausibile in chi affronta le sue composizioni con un approccio per l’appunto passivo, di chi si muove inerte all’interno del mondo dei suoi suoni, subendo e non interloquendo, lo stesso accade in chi si pone in maniera attiva, pronto a recepirne il costrutto, l’esplorazione timbrica, il suo rapportarsi con lo spazio oggettivo prima ancora che soggettivo. E ciò accade per un motivo assai semplice, quasi banale nella sua essenzialità, perché la musica di Davide Anzaghi esige pensiero, predisposizione al λόγος, a una capacità di porsi davanti a uno specchio sapendo che non ci sarà il Doppelgänger dell’ascoltatore riflesso, vale a dire il “duplice viandante” che è in noi, ma un vuoto che dev’essere riempito tramite l’ascolto stesso.
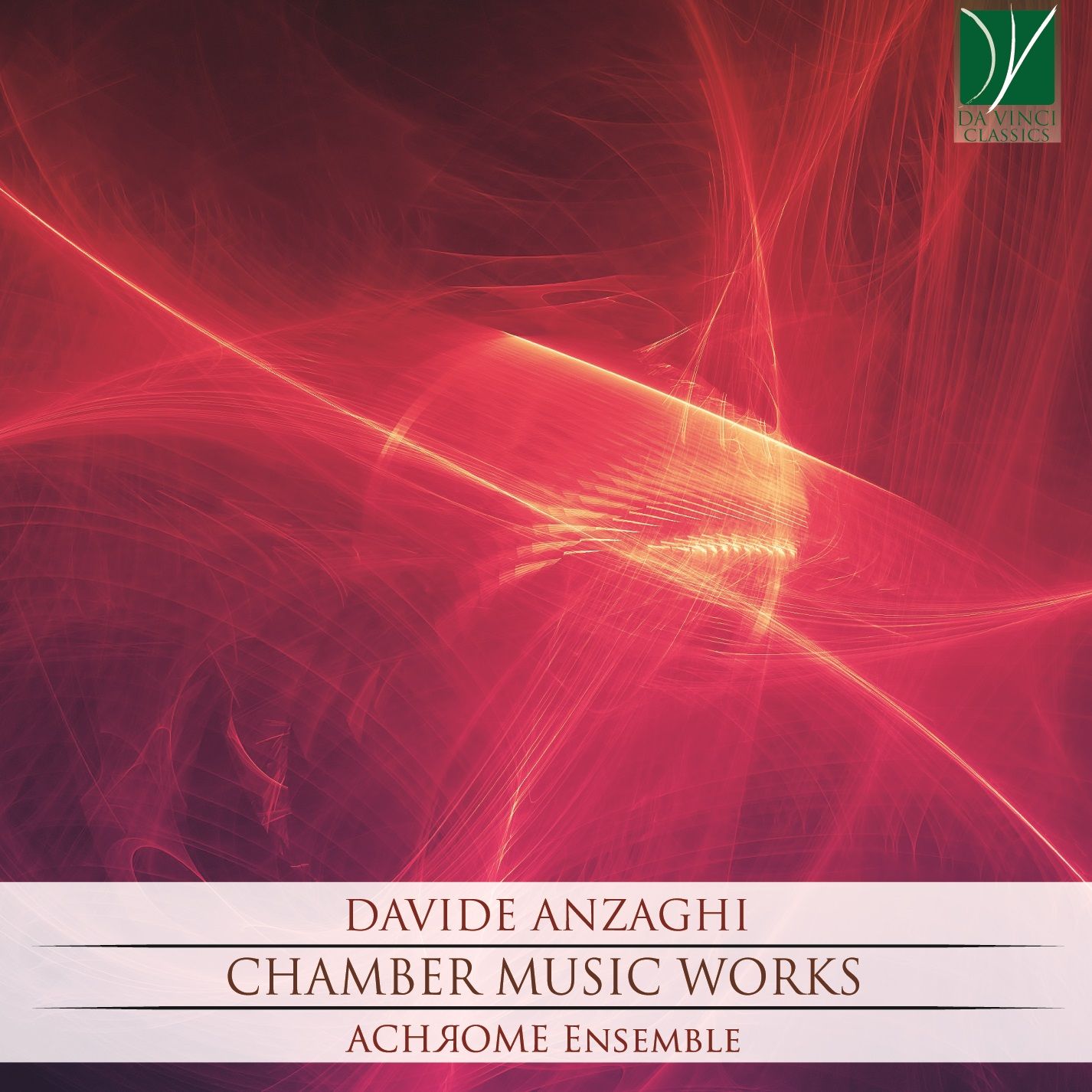
Ascoltare i suoni articolati, costruiti, sistematizzati nella musica di Anzaghi vuol dire mantenere alta la guardia di ciò che è una ricerca che si manifesta tale nel momento stesso in cui il rito dell’ascolto prende atto. Vi è un cammino parallelo, una rotaia che si materializza miracolosamente accanto a quella sulla quale procede l’ascolto e la sua assimilazione; per questo, se proprio dobbiamo definire la visione estetico-musicale del compositore milanese, possiamo utilizzare l’immagine di una simbologia sincronica, di un attuarsi parallelo che si realizza, oserei dire a livello olografico, nel momento stesso che il costrutto delle sue opere si dipana in suono. Tale immagine si rafforza, si delinea quasi con violenta certezza dopo l’ascolto del CD che l’ACHЯOME Ensemble ha registrato per la Da Vinci Classics presentando otto pagine cameristiche del musicista milanese, per la precisione Alm’Ala per pianoforte, violino, violoncello, flauto e clarinetti (2014), Oiseau triste per ottavino e pianoforte (1980), Rabesco I & II per pianoforte, violino, violoncello, flauto e clarinetto (2009-16), Eco, tre pezzi brevi per violoncello e pianoforte (1980), Elogio della luna per pianoforte, violino, violoncello, flauti, clarinetto e percussioni (2009), Spettri per violino e pianoforte (2002), Soavodìa per clarinetto e pianoforte (1980) e Lacerto per pianoforte, violino, violoncello, flauti, clarinetto e percussioni (2016). Opere che vanno a coprire, dunque, un lasso di tempo compositivo di quasi quarant’anni, con il compito di narrare in nuce, cosa che si pone di fare l’incisione in questione, l’evoluzione di un’idea multiforme capace di plasmarsi e di focalizzarsi nel corso del Χρόνος. “Tempo” che Anzaghi vive in modo sia lineare sia ciclico, ossia evolvendo e riprendendo quanto già assunto in precedenza, poiché una delle caratteristiche del compositore milanese è proprio quella di essere un maestro del bearbeiten di bachiana memoria, del “lavorarci sopra”, stratificando di composizione in composizione idee, immagini, segmenti cognitivo/speculativi da ampliare, perfezionare, calibrare, equilibrare nel tempo.

Vista sotto questa particolare angolazione, la scelta fatta dai componenti dell’ACHЯOME Ensemble (con Marcello Parolini alla direzione, Antonella Bini ai flauti, Marco Sorge ai clarinetti, Yoko Morimyo al violino, Emanuele Rigamonti al violoncello, Gabriele Rota al pianoforte ed Elio Marchesini alle percussioni) appare a dir poco esemplare, poiché la concatenazione dei brani, che non segue in modo pedissequo un approccio cronologico, risulta però essere anche squisitamente didascalica, dal sapore eminentemente “didattico”; partire da un’idea, da un Ding marxiano, da un presupposto in cui l’immagine cerca di trovare la sua materia per giungere a una supposizione timbrica, a una sua realizzazione materica che non deve mai scadere, però (Anzaghi ne è un nemico giurato), in una forma di ricerca fine a se stessa o in un Kreis esoterico, ma in una transizione altamente comunicativa che fa proprio della sua comunicazione la forza con la quale potersi esprimere.
E la forza che si fa comunicazione, veste nel compositore milanese diversi abiti, molteplici modelli in cui forme e colori si presentano con un fascino che lascia sconcertati per la capacità in cui la pochezza materica dell’impianto riesce ad assumere nel suo svolgersi risvolti e risultati così complessi. Si prenda, ad esempio, il brano più lungo qui presentato, Elogio alla luna, con i suoi dodici minuti, periodo temporale in cui la stabilizzazione timbrica dei vari strumenti chiamati in causa procede inesorabilmente a una sua progressiva realizzazione in cui trova infine equilibrio e raro bilanciamento. Un brano che è in fondo una “processione alla comunicazione”, un placido/inquietante incedere verso una forma in cui il materializzarsi sonoro assume le fattezze di un puzzle che è destinato a trovare tutti i tasselli, un dipinto in progress, un disvelamento seducente, sensuale, epidermico che si rivela alle orecchie di chi ascolta, incitandolo a percorrere insieme tale sentiero che conduce alla stabilità del presupposto iniziale.
E poi la capacità di specchiamento in due brani diametralmente opposti nelle finalità realizzative, nel loro materializzarsi e al loro porsi all’ascolto, come avviene prima in Spettri e poi, subito dopo, in Rabesco II (entrambi i brani vantano la stessa temporalità esecutiva), tra il primo, in bilico, a livello pittorico, tra i mostri generati di un Goya e le allucinazioni notturne di un Füssli, con il violino, quasi sempre annidato sul registro acuto, che va a ultimare ciò che il pianoforte dapprima elabora nel contesto oscuro della materia, come un bulino che sonda in un precedente intaglio; una stratificazione della materia che viene così destratificata, raschiata, asportata per mettere in mostra altri strati, altre immagini più o meno fuggevoli (il tasso di fuggevolezza è dato dalla presenza/assenza del pianoforte che aggiunge/toglie). Da parte sua, l’altro brano può essere il contraltare del suddetto, e va a sondare altri registri (si fissi l’attenzione su quanto il violoncello, sul registro medio-basso, riesce a mostrare all’ascolto), a riempire progressivamente dei vuoti non nelle linee, che sono precostituite, ma in ciò che tali linee indicano già nel loro percorso “arabesco”: sei minuti e diciassette secondi in cui i timbri strumentali vanno a colmare un qualcosa che non può essere lasciato vuoto, poiché per Anzaghi l’idea dell’arabesco ha una funzione che va ben oltre il ghirigoro piacevolmente estetico (se così non fosse, resterebbe solo un atto “esteta”), ma ha una sua “prassi” che dev’essere rispettata. Tale rispetto si attua nel momento in cui il suo riempirsi progressivo va di pari passo all’ascolto che facciamo di esso, quasi avesse un ruolo lenitivo diversamente alle angosce mostrate sotto la crosta del brano precedente.

Ma tutto ciò non deve farci dimenticare o mettere imprudentemente da parte il fatto che la produzione musicale di Davide Anzaghi è l’emblema di una classicità che non intende cedere le armi; anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, lo scopo precipuo del compositore milanese è quello di essere un appassionato testimone di tale classicità: la sua ricerca, difatti, non esclude mai una vocazione apollinea del suono, un suo articolarsi in una dimensione logica e naturale allo stesso tempo, di un suo porsi idealmente nello spazio, in miracoloso equilibrio (ancora!) tra l’elemento oggettivo che lo ammanta e lo circoscrive e l’elemento che lo coglie e lo ingloba a livello di ascolto; in tal senso i tre brevi brani di Eco rappresentano un esemplare modus essendi del suo concepire una musica che deve fare inevitabilmente i conti con una purezza formale che, nelle intenzioni del suo autore, non deve mai venire meno, anche se questo côté apollineo a volte riesce perfino ad andare oltre la dimensione orgiastica del dionisiaco, come ben ci ricordano i mirabili scritti di Giorgio Colli. Quindi, anche la musica di Davide Anzaghi può manifestare una connotazione “sapientemente” tellurica, anche se tale telluricità assume sempre i contorni di un’ira furor brevis est, di una virulenza dialettica che alla fine, però, abbassa sempre i pugni, in nome di quel λόγος che non deve mai venire meno e che rappresenta per il compositore milanese una stella polare sulla quale posare sempre lo sguardo creativo.
La capacità immedesimativa che i componenti dell’ACHЯOME Ensemble sono riusciti a fornire in questi brani è davvero ammirevole; la nettezza delle proporzioni timbriche, la sempre dosata volumetria che sono riusciti a esprimere fanno comprendere come dietro tali letture vi sia una comprensione a dir poco ideale della loro essenza, quasi fossero pregni del λόγος che si irradia da queste composizioni. Ogni timbro, ogni sfumatura, ogni enunciazione sonora hanno una loro duplice funzione: a sé stante e in accordo con ciò li precede e li segue; ne consegue una linearità, una naturalezza emissiva che tende proprio a esaltare quel principio di “classicità” che intride la poetica musicale di Davide Anzaghi.
La presa del suono effettuata da Simone Gallizio restituisce felicemente la dimensione squisitamente spaziale di queste composizioni; ciò lo si deve a una dinamica effervescente, energica, capace di esaltare i transienti, persino nelle sue sfumature più tenui (da qui, una più che apprezzabile microdinamica). Il palcoscenico sonoro è capace di ricostruire idealmente i vari interpreti e gli strumenti all’interno dello spazio fisico posto tra i diffusori, non lesinando in fatto di ampiezza e di altezza l’immagine sonora. Ottimi anche gli altri due parametri, con l’equilibrio tonale che risulta essere sempre rispettoso nel restituire i registri dei vari strumenti, dall’acuto dell’ottavino fino al grave del violoncello, così come il dettaglio è foriero di una notevole matericità.
Andrea Bedetti
Davide Anzaghi – Chamber Music Works
ACHЯOME Ensemble
CD Da Vinci Classics C00121


