ù si conosce un compositore, più diventa difficile parlare di lui. E questo per due motivi diametralmente opposti: se il primo è dettato dal fatto che non si può più discuterne per il semplice fatto che si è già detto tutto quello che poteva essere spiegato della sua opera, il secondo, invece, è dato dal fatto che continua a presentare, offrire, mettere in campo scorci della sua personalità e della sua sensibilità creativa tali da mettere in difficoltà colui o coloro che intendono sceverarla.
Il compositore e filosofo milanese Carlo Alessandro Landini appartiene di diritto alla seconda categoria di musicisti, in quanto la complessità complessiva della sua opera, per via degli intrecci, delle ricerche, delle applicazioni ai quali sottopone la sua musica, lo pone in una posizione che costringe critici e studiosi, come il sottoscritto che ne ha parlato spesso e soprattutto volentieri, a un doveroso supplemento d’indagine, il quale, di converso, si trasforma per nostra fortuna in una forma di prezioso arricchimento personale. Come nel caso di questo doppio CD, pubblicato dall’etichetta Tactus, che riguarda la ristampa inerente alle registrazioni fatte dal pianista milanese Carlo Levi Minzi della Sonata n. 1 per pianoforte (effettuata per la precisione il 22 giugno 1981) e della Sonata n. 2 per pianoforte (risalente al 25 novembre 1997) di Landini e uscite all’epoca per un’altra label, esattamente la Rugginenti.
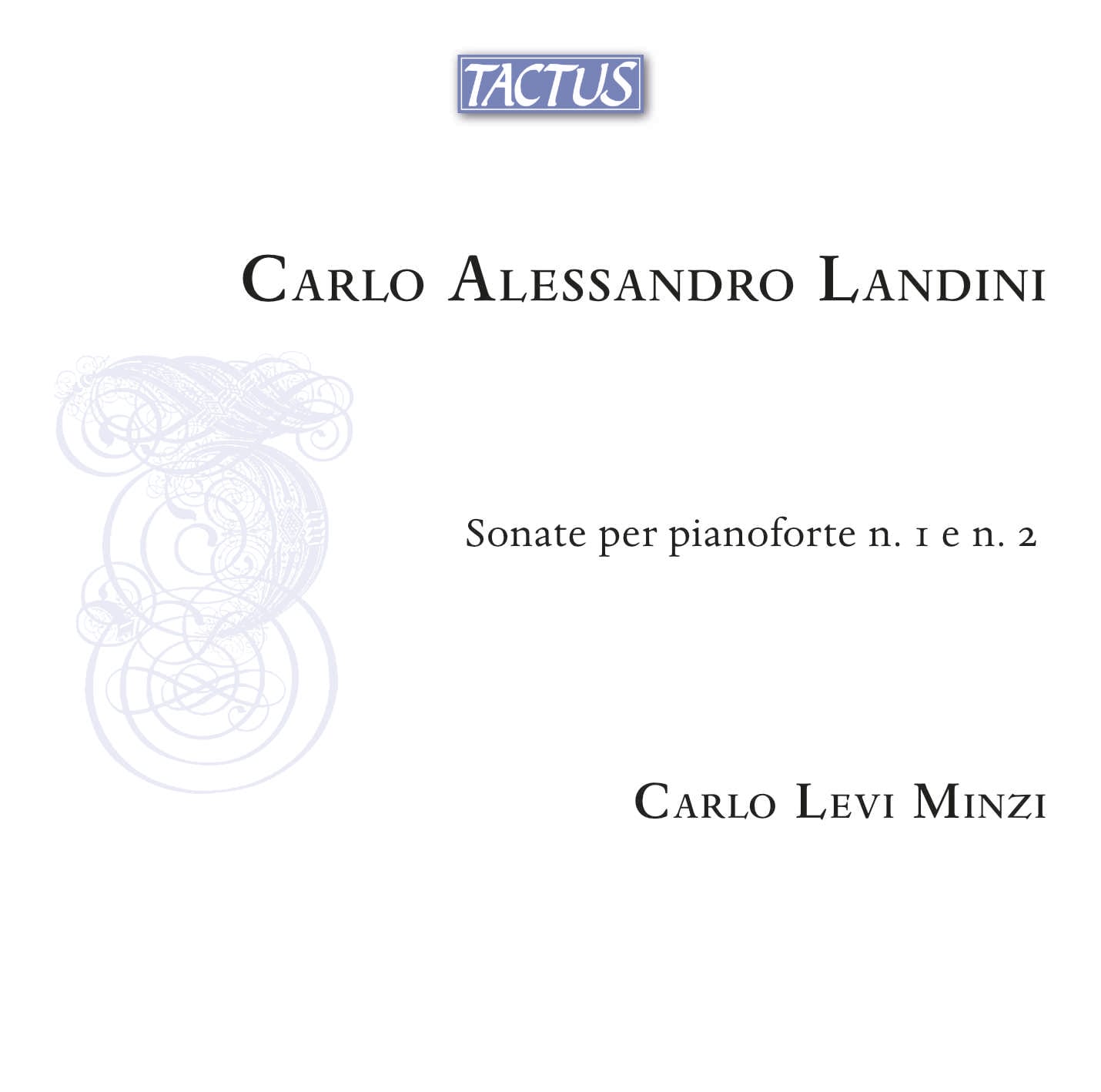
Quindi, ci troviamo di fronte all’inizio di quell’impervio e meraviglioso sentiero sonatistico del compositore milanese che, nello scorrere del tempo, lo ha portato a creare altre cinque sonate (l’ultima, l’ottava, risale al 2021). Non credo di cadere in fallo, se affermo che è proprio attraverso questo genere musicale che Landini ha saputo affinare e concentrare in modo assoluto, almeno per quello che è la sua “fede” artistica, la punta suprema della creatività sonora (non per nulla, la pianista e musicologa Antonietta Incardona ha dedicato a queste Sonate un illuminante saggio, Il tempo della musica. Le Sonate per pianoforte di Carlo Alessandro Landini, edito sempre da Rugginenti, frutto della sua tesi di laurea). Ora, una “punta suprema” può essere definita tale quando fin dalla prima manifestazione di un genere destinato a durare e ad ampliarsi negli anni la chiarezza, la lungimiranza, l’“illuminazione” (su quest’ultimo termine tornerò nel corso della mia analisi) creative sono raggiunte e scolpite, proprio come è avvenuto nella Sonata pianistica in Landini. Se anche ai più grandi l’avvio di un percorso compositivo è stato soventemente segnato dall’impronta di un tentativo, di un’“esplorazione” con i quali affinare, levigare, lavorare incessantemente con il bulino, nelle sue Sonate per pianoforte il compositore milanese ha trovato fin da subito la sua Heimat, termine con il quale non si vuole intendere solo la “patria” in senso lato, se consideriamo l’accezione data dalla lingua tedesca, resa dal lemma Heim, che vuol dire “casa propria”, ma che idealmente può essere rappresentato come “grande casa”.
Per Landini, dunque, la Sonata pianistica è la “grande casa” nella quale riconoscersi in tutto e per tutto, il luogo nel quale prima o poi, come ammonisce l’aforisma novalisiano, “tutti noi torniamo”. Questo concetto, a dir poco sacro per il Romanticismo tedesco per la potenza simbolica che rappresenta, viene condiviso dal nostro compositore che lo ha magistralmente applicato alla tastiera del pianoforte fin dalla Sonata n. 1, immettendo in essa fin da subito un DNA che ha marcato anche le opere seguenti di questo genere. A cominciare da un’inusitata lunghezza (sia la Sonata n. 1, sia la successiva sfiorano ognuna i settantacinque minuti di durata); una caratteristica, questa, sulla quale in passato mi sono già ampiamente soffermato, ma che qui posso riassumere con un’immagine immediata e chiarificatrice: ogni “grande casa” che si rispetti ha varie stanze, saloni, spazi adeguati nei quali potersi muovere al punto da poter adottare la simbologia di un labirinto in cui lo spazio e il tempo tendono a confondersi. Inoltre, riflettendo sul dipanarsi della materia sonora elaborata da Landini nelle sue Sonate pianistiche, ci si rende conto che l’inusitata lunghezza delle medesime non si rispecchia tanto sulle dimensioni schubertiane delle ultime Sonate e sulla Sinfonia Die Große, quest’ultima tanto decantata dalla critica schumanniana, nelle quali il tempo tende a scorrere linearmente, quanto su una concezione attraverso la quale il tempo si avvolge circolarmente, sui modelli prossimi alla filosofia e alla musica induiste.
A questo punto, a cominciare dalle prime due Sonate landiniane, si potrebbe già prospettare una tematica comune anche alle altre che sono seguite, ossia che qui la loro lunghezza più che altro si trasforma in una mera illusione temporale, se consideriamo il fatto che nella nostra percezione di ascolto una linea intessuta di tempo che si avvolge attorno a se stessa vanta di conseguenza una spazialità più ristretta, il che porta il suo rapporto spazio/tempo a vantare una spaventosa densità del suo essere in sé. Per questa ragione, se si affronta il loro ascolto adottando il principio di uno scorrere lineare del nostro tempo interiore, si viene implacabilmente rigettati, rifiutati dall’atto dell’ascolto stesso, in quanto la materia sonora intrisa in esse diviene repellente, ostica, urticante; se si fa ciò, subentra un fattore di estraniamento, di un qualcosa nel quale ci si perde (ciò può essere utile quando si ascoltano le opere di un Morton Feldman, visto che lo stesso compositore americano suggeriva di farlo), il che significherebbe snaturare l’obiettivo del musicista milanese, nel quale il fare musica, così come il suo ascoltarla, segue programmi di assoluta razionalità.
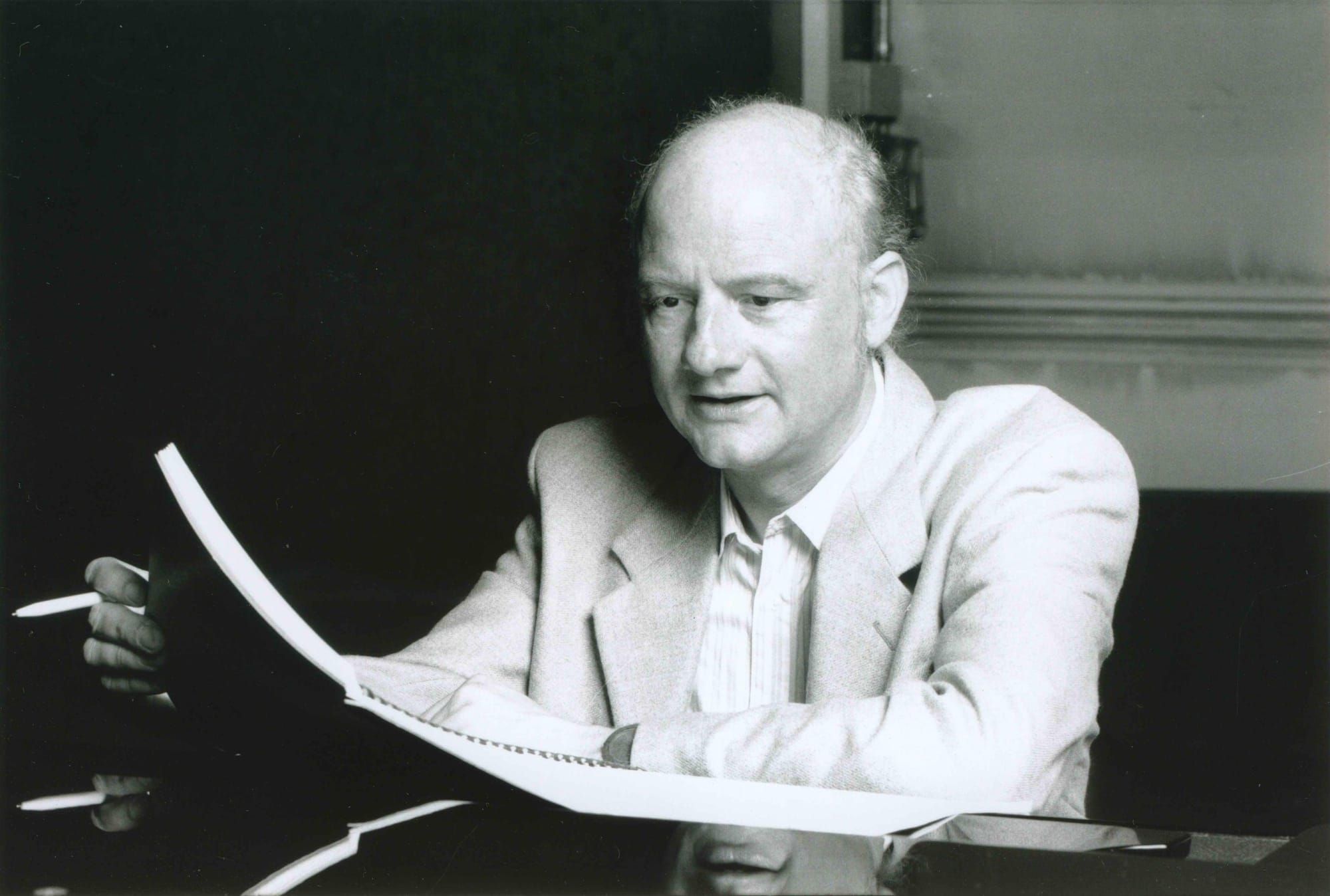
Questa razionalità è dettata da un impianto armonico che è proverbiale in Landini, capace di plasmare come pochi l’armatura architettonica delle sue composizioni, le quali, è bene ricordarlo ancora, non hanno nulla a che fare con sperimentalismi o rotture atomizzanti nei confronti del linguaggio tonale. Il fatto, però, come dimostrano esemplarmente le due Sonate in oggetto, è che questa razionalità porta la materia sonora ad essere sfuggente, più viscida di un’anguilla se non si adotta quella capacità di ascolto che dev’essere altrettanto avvolgente, passando da uno stato all’altro di microuniverso, sempre cangiante e mutante, ma tenuto saldamente unito al macrouniverso globale da accordi che restano fissi, stabili nel corso dell’intera Sonata che non presenta frazionamenti in tempi (nel caso specifico, nella Sonata n. 1 gli accordi agglutinanti sono rappresentati dall’uso della quarta e della quinta, che tendono quindi a una meta perfettibile, mentre nella Sonata n. 2 quelli basati sul rapporto tra il do bemolle e il re bemolle, portano a un risultato realmente ipnotizzante).
A questo punto, ci possono essere due chiavi di lettura/ascolto per quanto le riguarda. Per la Sonata n. 1 ipotizzo l’aiuto di un ricorso, fornito dalla dimensione assimilante del Vedanta induista, più precisamente dal principio supremo del “non duale”, poiché fin da questa Prima Sonata Landini aggredisce l’ascoltatore immergendolo nella sfera del “non-finito”. Nella filosofia del Vedanta, il “non finito” viene indicato dal termine ananta (in sanscrito अनन्त) che, radicato nella densissima espressione rappresentata dall’ashram «Anadi [senza inizio] Ananta [senza fine] Akhanda [ininterrotto] Satcitananda [essere-coscienza-beatitudine]», porta a comprendere meglio la dimensione dell’“Infinito” come realtà unica e, quindi, “non duale”. Graficamente, il concetto di Ananta è dato dal serpente cosmico che tutto avvolge, avviluppa, con tutte le cose che, grazie ad esso, si stringono in una spirale; questo concetto straordinario, assoluto, fu studiato a Katmandu dal sacerdote cattolico inglese Bede Griffiths, un benedettino camaldolese che alla fine della sua vita si fece chiamare Swami Dayananda (ossia “beatitudine della compassione”), fautore di un sincretismo tra esperienza monastica cristiana e saṃnyāsa induista, un termine che nella lingua sanscrita ha il senso di “abbandono definitivo”.
L’Ananta che si annida nella Sonata n. 1 di Landini e che avvolge tra le sue spire è dato dal suo “non-inizio” e dalla sua “non-fine”, con il tema iniziale che torna a ripetersi (ininterrottamente) alla conclusione (?) della composizione, un mantra purificatore che conduce l’ascoltatore a collaudare con l’attesa di un linguaggio sonoro quanto aspirano coloro che intendono perseguire il lungo e tortuoso sentiero della moka, dell’“illuminazione”. Naturalmente, quasi non ci fosse il bisogno di enunciarlo a chiare lettere, Landini non mira a diventare uno Swami (स्वामी), come vengono definiti nella filosofia induista i “maestri”, “coloro che sanno”, quelli che giungono per l’appunto al termine di questo sentiero, ma è indubbio che il suono, che incessantemente materializza nella forma fissata e perpetuata, ha un valore “etico”, cosa che ho già rimarcato in passato, ma che intendo qui ribadire anche alla luce di quanto ha scritto Antonietta Incardona nel suo citato saggio, vale a dire che «Landini ama il suono bello», un’affermazione, questa, che posso accettare solo se dietro tale presenza “estetica” si celi anche un’essenza “etica” della sua musica. Sono fermamente convinto che per il compositore e filosofo milanese il suono sia strumento e fine allo stesso tempo, strumento per coinvolgere e fine per gli obiettivi non solo artistici che si pone, poiché la sua musica dev’essere necessariamente pensata/ascoltata/ri-pensata; un processo a dir poco indispensabile per poterla acquisire nella sua totalità.
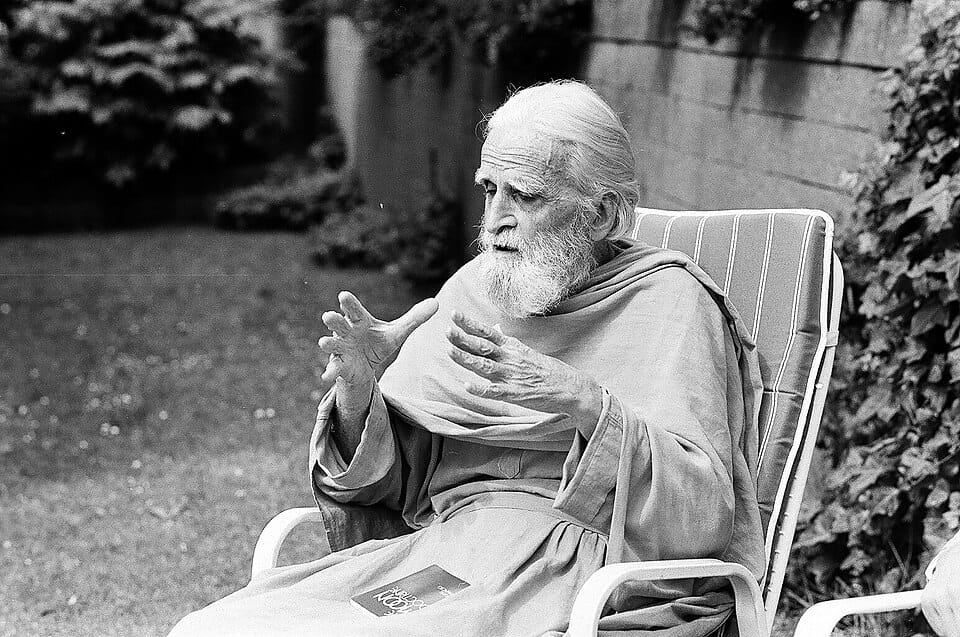
Questa totalità si acuisce ulteriormente quando si affronta la Sonata n. 2: qui, come osservava giustamente Francesco Leprino nelle note di accompagnamento del CD della Rugginenti, l’ossessività benefica e reiterata data da una sesta eccedente fornisce un approccio all’opera che rimanda all’accordo di mi maggiore che permea, fin dal pedale iniziale de Das Rheingold, tutta la Tetralogia wagneriana. Tale tipo di accordo, realmente ossessivo, assume al primo ascolto, del tutto inutile se tale rimane, un impatto repulsivo, perfino estraniante che porta l’ascoltatore a rigettare d’acchito l’impianto architettonico della Sonata. Il concetto del Satcitananda evocato nella Sonata n. 1 si trasforma apparentemente in un apparato che nella sua espressione formale non invita a una consonanza benefica, balsamica, ma in un procedere singhiozzante, alterante, sebbene a tratti ancora avvolgente. Ma si tratta solo di un “falso inganno”, un tentare l’ascoltatore ad affrontare cammini differenti, binari morti coperti da foglie marcite autunnali, quando invece è lo stesso Landini a tendere la mano verso chi ascolta per portarlo sulla retta via di una dimensione appropriata, reale, lucida, adamantina.
Solo dopo diversi, umili ascolti si ha così, tornando agli echi della Tetralogia, l’affiorante percezione che, attraverso il fulgido impianto armonico iniettato, questa Seconda Sonata sia in realtà una commovente ninna-nanna, la cui impronta prende le mosse da quella che Wotan proietta a Brunnhilde nel finale titanico de Die Walküre. Una ninna-nanna il cui scopo precipuo è quello di insufflare un sonno redentore (non vorrei farmi prendere la mano, ma vorrei che l’idea di questo sonno fosse considerato alla stregua di un emergere della vera natura umana che, secondo la tradizione orfica, si presenta autenticamente solo quando gli uomini si addormentano, non più vittime del volere malvagio dei Titani che li dominano durante il loro essere “svegli” e coscienti).
Da tali premesse si comprende come la Sonata n. 2 sia un’opera che dev’essere scavata nel suo ascolto, così come nella sua resa esecutiva, stridor di denti che si irradia in una carezza salvifica, tempesta immota, violenza arrotondata che conduce a una vetta (e che deflagra nel centro esatto del suo dipanarsi) e che mima l’ascesa dell’Alpensinfonie straussiana in coincidenza con il funesto temporale che investe l’escursionista, atto purificante, capace di detergere, di pulire, di elemento cancellante, ergo positivo nella sua opera di dissolvenza. Ecco perché il motto di questa Sonata potrebbe essere quanto esclama Wotan quando con la punta della sua lancia traccia una linea di fuoco per proteggere il sepolcro nel quale Brunnhilde dorme eternamente per espiare la sua colpa: « Chi teme la punta della mia lancia, mai attraversi il fuoco!». Il muro timbrico che Landini fa esplodere nel cuore di questa sua composizione vuole essere “fuoco”, linea capace di separare coloro che intendono essere purificati da quelli che invece credono impunemente di essere dei novelli Prometei, destinati ad offrire il fegato del loro non-ascolto.

Riascoltando la lettura fatta da Carlo Levi Minzi di queste due Sonate, non posso che ribadire che qualunque pianista accetti di affrontare il corpus sonatistico del compositore milanese non può che essere un visionario temerario, destinato a trionfare o a soccombere. Per nostra fortuna, quanto fatto dal pianista milanese in queste due registrazioni appartiene al primo caso, poiché è riuscito in una duplice impresa; se nel caso della Sonata n. 1 è stato in grado di reggere la pressione imposta dal disciplinare la struttura ipnotizzante di tutto l’impianto strutturale, con una sapiente miscelazione timbrico/ritmica, nella Sonata n. 2 ha trasformato veramente la tastiera nella lancia magica di Wotan, dominando le terribili escursioni armoniche atte a deflagrare la materia sonora. Dalla loro esecuzione sono trascorsi per l’esattezza rispettivamente quarantaquattro e ventotto anni, ma a tutt’oggi non hanno perso un’oncia della loro efficacia e della loro bellezza.
La stessa cosa, invece, non si può dire per la qualità della duplice presa del suono, effettuate da Jacques Leblond (1981) e da Carlo Tedeschi (1987), in quanto risentono, soprattutto la prima, di un procedimento che non era stato ancora affinato tecnicamente. Se la presa di Leblond, per esempio, manifesta una timbrica “metallica” che investe il registro acuto, cosa assai frequente all’epoca, quella di Tedeschi nel parametro del palcoscenico sonoro è alquanto piatta e nel dettaglio lo scontorno dello strumento risulta essere assai approssimativo. Inoltre, nella Sonata n. 2 il lunghissimo passaggio in cui la dinamica è oltremodo sollecitata in ff e fff l’equilibrio tonale ne risente per via di un fastidioso impasto tra il registro acuto e quello medio-grave. Ma, ripeto, ci troviamo di fronte a due registrazioni che sono state riproposte tel quel dalla casa discografica, senza aver adottato, a quanto pare, un intervento di “pulizia” e di miglioramento della presa del suono originale.
Andrea Bedetti
Carlo Alessandro Landini – Sonate per pianoforte n. 1 e n. 2
Carlo levi Minzi (pianoforte)
2 CD Tactus TB 951290
Giudizio artistico 4,5/5
Giudizio tecnico 3/5



