Leggendo la lista dei nomi-guida che l’arpista Giuliano Marco Mattioli, protagonista del disco Notte. Solo Harp Nocturnal Works of the 20th Century, pubblicato dalla Da Vinci Classics, ha elencato nelle sue note di accompagnamento, ho capito fin da subito che mi avrebbe atteso un ascolto proficuo, basato non solo su un sentiero costellato da diversi autori del Novecento storico e di quello più vicino a noi, ma soprattutto basato su uno spessore speculativo che è, come ricorda il filosofo della musica Vladimir Jankélévitch (guarda caso, citato anch’egli dall’artista di Lovere), il fine ultimo della vera, unica Musica. Ho tirato un sospiro di sollievo, tenuto conto che non avrei dovuto a che fare con puttanate salottiere o con minestre trite, ritrite e sbattute in faccia nel loro riscaldarsi senza soluzione di continuità.

Lo spessore speculativo in questione, presente in tale progetto discografico, viene fissato nel concetto della notte, affrontato, decodificato, immaginato attraverso l’utilizzo dell’arpa nelle creazioni di compositori quali Vincenzo Zitello, Luciano Berio, Carlo Galante, Carlos Salzedo, Susann McDonald, Linda Wood, Albert Zabel, Vasilij Ivanovič Vinogradov, Henriette Renié, Kurt Weill, Bernard Andrès e Marius Flothuis, ossia con una dimensione temporale che va dalla prima metà dell’Ottocento con Zabel e che arriva fino ai giorni nostri con Zitello, Galante, McDonald, Wood e Andrès. Un viaggio al centro della notte, dunque (parafrasando il disperato genio di Courbevoie), che viene sagacemente annunciato dalle immagini della cover e del retro, dedicate a due disegni di Odilon Redon, uno che alla notte e ai suoi significati dava tranquillamente del tu, e che Mattioli affronta con la giusta dose di timore/tremore di kierkegaardiana memoria, senza dover ricorrere a chissà quali sperimentazioni fornite da messe di bruits o da ricorsi cacofonici, ma mediante la lettura di brani che sono prodigiosamente evocativi nel loro linguaggio tonale.
È lo stesso interprete lombardo a spiegare nelle note come la sua idea di arpa si sia differenziata fin dagli anni dello studio da quella consueta e annosa, ossia uno strumento musicale contrassegnato da «qualità come la dolcezza, la grazia, la femminilità»; non solo, ma affascinato dalle tematiche estetiche e poetiche del simbolismo, Giuliano Marco Mattioli ha voluto esemplificarle attraverso una ricerca che permettesse all’arpa di far affiorare quanto il concetto della notte, delle tenebre, dell’indeterminatezza delle cose e delle forme viene espresso dalla potenza e dalla profondità del suono (sempre fedele a Redon, il nostro artista riporta una sua famosa espressione: «La musica è un’arte notturna, l’arte del sogno; essa regna in inverno, nel momento in cui l’anima si rifugia»). Da ciò alla dimensione che assomma la notte con la proiezione dell’inconscio il passo è breve. Così, l’idea di questo progetto discografico, come ricorda lo stesso Mattioli, maturata in un arco temporale di oltre dieci anni, si è basata «tanto sulle qualità compositive quanto sulle contrastanti caratteristiche evocative dei brani, integrandole con elementi propri della letteratura, dell’arte figurativa, della psicodinamica: simbolo, mito, archetipo, sogno, inconscio, silenzio, proiezione».

Ecco, allora, che la costruzione di questo rapporto notte/inconscio avviene mediante la realizzazione di un racconto/sentiero che parte da un alfa per concludersi con un altrettanto ideale omega, fermo restando che la scelta delle pagine fatte dall’arpista lombardo rappresenta la sua “idea” sensibile di tale rapporto e che, di conseguenza, può o meno essere aderente nei confronti dell’ascoltatore, il quale, però, può evocare attraverso i suoni promossi, la sua immagine di una specifica oscurità che si riflette nel proprio inconscio. Le tappe di questo viaggio hanno avvio con un brano che il compositore ed arpista Vincenzo Zitello ha appositamente scritto per Mattioli, Prologo verso la notte, in cui la dimensione sonora, manifestata dal concetto della reiterazione, rimanda all’attività incessante dell’uomo che, al tramonto, rallenta fino a rarefarsi, lasciandosi alle spalle la vita quotidiana e facendo sì che la coscienza possa finalmente lasciare spazio all’inconscio, quando sensi e percezioni si rimodellano e nel paesaggio psichico tutto diventa meno definito.
Segue la meravigliosa canzone popolare armena Loosin yelav, che Berio trascrisse per la voce di Cathy Berberian e sette strumenti con le altre dieci che formano il corpus dei Folk Songs; questo struggente pezzo è stato inserito (nella versione in prima assoluta per sola arpa e con la voce dello Mattioli) dall’interprete per rendere omaggio a un altro simbolo eccelso che affiora con l’irruzione della notte, la luna, vista nella sua dimensione crescente, emanazione di una proiezione benefica, protettiva, così come si realizza, al contrario, anche la sua immagine calante (che nell’immaginario popolare e atavico incarna la sfera femminile) nel brano successivo, The Waning Moon - Poemetto notturno, composto da Carlo Galante nel 1983. Tale scelta viene ulteriormente specificata dai versi del poema To the moon di Percy Bysshe Shelley che l’autore ha apposto sulla partitura: «La luna sorse nell’est nebuloso, una massa bianca e informe», proponendo, dunque, l’altra sua faccia, quella indistinta, sfuocata, indecifrabile, come può esserlo la creatura femminile, paragonata al satellite naturale, morente, pallida, folle.

Questo sorgere e calare, nascere e morire rappresenta un cardine fondamentale nella costruzione dell’edificio psicoanalitico, il cui fascino spinse il compositore e arpista statunitense Carlos Salzedo a creare nel 1917 Five Preludes (Quietude - Iridescence - Introspection - Whirlwind [Tourbillon] - Lamentation), di cui Mattioli ripropone qui il terzo, da intendere come riflessione sulla propria esistenza, stimolata sempre dalla presenza della luna. Il principio della riflessione, dell’introspezione viene fornita dai gruppi di quintine, che si ripetono attraverso una stratificazione mentale al punto da dare vita a una materializzazione ipnotica e che porta alla fine del brano, definito Vision, uno stato alterato della coscienza che permette all’inconscio di emergere, grazie a un fascinoso utilizzo di glissandi.
La luce lunare, però, è capace di generare il mistero dell’ombra, la cui stilizzazione, la cui essenza si identificano con il principio dell’haiku nipponico, colmo di una prodigiosa condensazione espressiva, e le due brevi pagine delle compositrici ed arpiste americane Susann McDonald e Linda Wood Rollo, After the moon-viewing, my shadow… e Distant lights; There they live…, entrambe tratte dalla loro raccolta Haiku, forniscono i tratti ultimi, tramite un affioramento liofilizzato, sia dell’emanazione della “linea d’ombra”, sia di luci abitative che spuntano dalle tenebre e che nella loro disposizione più o meno casuale forniscono un’immagine “comunitaria”, di unità palliativa di fronte al muro delle tenebre.

Il tardoromanticismo musicale, quello espresso dal tedesco Albert Heinrich Zabel (autore esclusivamente di musica per arpa), è chiamato in causa da Giuliano Marco Mattioli per raffigurare un altro principio indissolubile legato al culto della notte, quello del sogno, con il brano Rêve d’amour, in cui la dimensione onirica è in realtà la manifestazione di desideri cullati e di passioni mai sopite e che l’irruzione delle tenebre porta ad accelerare la loro conglomerazione proiettante. Subito dopo, sulla falsariga di quanto fatto da Berio, seguono le Variations on the Russian Folk Theme “Nochenka” del tataro Vinogradov, un brano a dir poco straordinario in fatto di virtuosismo ed espressività, realizzato sull’antica canzone popolare russa Piccola notte, il cui testo ci ricorda come le tenebre possono essere anche elemento di compagnia e di consolazione per chi è costretto alla solitudine, e che in chiave orientale possono rimandare al concetto del Wanderer schubertiano.
Ancora una compositrice femminile, la francese Henriette Renié, allieva del leggendario Alphonse Hasselmans, autrice del brano Feuille d’automne, ispirato dai versi de La prière pour tous di Victor Hugo, in cui fa il trionfale ingresso la natura nella quale riversare nell’indistinzione notturna il bagaglio represso di emozioni, sensazioni, immagini, proiezioni pompate dal nostro inconscio, liberate dal balsamo delle tenebre, che tutto accolgono e accettano. Ma anche nella notte il rovescio della medaglia, prima o poi, si presenta e Kurt Weill lo evoca nel 1934, quando il nazismo s’irrobustisce in Germania, attraverso la figura di un orco, Le grand Lustucru, già utilizzato in un’antica canzone popolare francese, e che confluisce nelle musiche di scena che il compositore tedesco scrisse per una pièce di Jacques Deval, Marie Galante, opera del tutto dimenticata, complice il sonoro fiasco della prima, avvenuta a Parigi in quello stesso anno. Tipico nello stile weilliano, Le grand Lustucru è una spettrale ballata che rimanda, a livello stilistico e di sapore musicale, a quelle eruttate durante il magico sodalizio con Bertolt Brecht, ma la cui densità è ormai un triste ricordo. Sono i mostri di Poe e del “solitario di Providence” Lovecraft, autori amati e metabolizzati dall’adolescente Mattioli, a fare capolino, in qualità di rigurgito per essere metabolizzato e reso digeribile in fatto di transfert analitico, con lo stesso arpista che intona gli inquietanti versi.
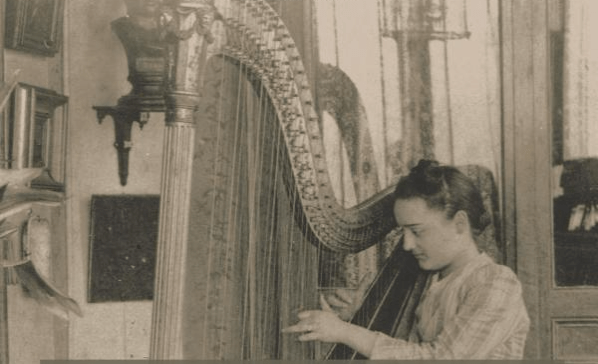
In che modo, quindi, difendere il nostro “fanciullino” pascoliano di fronte alle minacce del bau bau notturno? Con l’arma dell’umorismo, il potente faire semblant umano capace di esorcizzare paure e angosce, sorriso e risatina quali scudo con il quale proteggerci dalle ombre e dal buio che apparentemente non riusciamo a decodificare e a rendere inoffensivo. Così, l’arpista lombardo fa intervenire Bernard Andrès e la sua Calembredaine nelle fattezze di una tachipirina per l’anima spaventata. Il termine francese di calembredaine significa sciocchezza, non-sense, e in questo suo brano del 2012 il compositore ed arpista francese utilizza tutta la sua perizia tecnica per elaborare una linea ritmica e serrata con la quale, evocativamente, spazzare via, nell’immaginario del nostro interprete, l’assedio della paura notturna.
Il ritorno del retaggio psicoanalitico è dato invece dal quinto e ultimo dei Five Preludes di Salzedo, Lamentation, che dà luogo al senso di colpa, ossia al principio di consapevolezza nell’aver distrutto a causa di una disattenzione, di un cosiddetto “atto mancato”, ciò che si amava di noi, e che fa ineluttabilmente parte dell’“altro” che alberga sempre in noi. Così il lamento che affiora è reso da suoni duri, scolpiti, inesorabili come una marcia funebre, martellate ritmiche che sono gocce che bucano la pietra, frecce che si piantano nel nostro essere San Sebastiano. Solo un sonno ristoratore, infine, può placare tale macerazione, questa contrizione soffocante. E il sonno apre la porta al sogno, ossia al mito di Orfeo, che s’incammina in una ricerca dell’inconscio che ha le fattezze di un’Euridice: è il brano conclusivo, Pour le tombeau d’Orphée, del musicologo e compositore olandese Marius Flothuis (a suo tempo anche direttore artistico della Concertgebouw di Amsterdam). Sonno, sogno, un’altra morte che non rappresenta una fine, ma un nuovo inizio, una ri-nascita, come quella del mitico semidio che, una volta tornato dall’Ade, fu fatto a pezzi dalle Menadi, perché senza la sua Euridice non più attratto dal fascino muliebre. Eppure, anche dopo la morte, Orfeo continuò a cantare con la sua testa, una volta giunta spinta dalla corrente fino all’isola di Lesbo, assurgendo al livello di un venerato e rispettato oracolo. Una fine che si tramuta dunque in “altro”, magari in ricordo, in rimpianto, in dolore da mitigare con il tempo; è questo ciò che deve aver provato Salzedo, quando compose la sua Lamentation, frutto di un lutto privato, ossia la morte del suo ciuffolotto Baron Taraky, al quale il brano fu dedicato. Una notte, prima di andare a dormire, l’arpista americano lasciò la gabbia dell’uccellino su un radiatore apparentemente inattivo. La mattina seguente, però, scoprì l’amato pennuto senza vita, ucciso dal calore sprigionato dal radiatore durante la notte. Ecco perché alla fine del pezzo viene ripreso l’accompagnamento iniziale, imprimendo così alla pagina una sua una circolarità, evocando il simbolo dell’uroboros, vale dire il serpente che si morde la coda a rappresentazione del concetto di eternità: dove la vita viene sostituita dalla morte, il ricordo e l’amore mordono la coda per permettere alla ciclicità di non decretare mai la parola fine.

Questo viaggio, come si è potuto comprendere, è frutto di diverse tappe, una diversa dall’altra, che corrispondono ad altrettante necessità interpretative; stili diversi, ritmi, soprattutto interiori, differenti, per non parlare delle molteplicità espressive che queste pagine esigono in modo inappellabile. Certo, che se Giuliano Marco Mattioli ha voluto mettersi alla prova, non solo per dare concretezza al bisogno del suo viaggio notturno all’interno del quale dare vita al mistero sonoro, ma soprattutto per dimostrare a sé stesso e a chi lo ascolta di essere in grado di dominare lo strumento arpa e il suo linguaggio, allora possiamo affermare che vi è riuscito più che bene. Tecnica, sensibilità, dominio della materia musicale, dono dell’espressività, chiarezza d’intenti e capacità di trasfigurare il suono a seconda delle esigenze date dalla varie partiture: questo è il catalogo che viene fuori dalla sua affascinante e coinvolgente lettura, che può essere riassunta in un libro fatto di tanti capitoli, in ognuno dei quali dimostra di essere non solo convincente per lucidità ed eloquio del gesto, ma anche di saperli armonizzare e uniformare attraverso un filo unitario, dando vita a una matassa che non è mai aggrovigliata, ma che si presenta come un filo sempre perfettamente dipanato al quale avvinghiarsi per affrontare questo suo meraviglioso viaggio nel cuore notturno dell’arpa. Da ascoltare e riascoltare, per scoprire immancabilmente qualcosa di nuovo e di inesplorato.
La presa del suono, effettuata nello Jul’s Harp di Cesano Maderno (non è indicato il nome del tecnico che lo ha fatto), è di ottima fattura e va a completare la preziosità di questa registrazione. La dinamica è assai corposa e molto dettagliata, ricca di velocità e di naturalezza, così come la ricostruzione del palcoscenico sonoro pone l’arpa al centro dei diffusori a una discreta profondità di campo. L’equilibrio tonale è contrassegnato da una notevole pulizia del registro medio-grave e di quello acuto e, infine, il dettaglio manifesta generose dosi di nero intorno allo strumento, esaltando la sua fisicità e impedendo di conseguenza un ascolto faticoso.
Andrea Bedetti
AA.VV. – Notte. Solo Harp Nocturnal Works of the 20th Century
Giuliano Marco Mattioli (arpa)
CD Da Vinci Classics C00720


