Che il jazz europeo, compreso quello di matrice italiana, non abbia ormai più niente da imparare o invidiare a quello statunitense, è ormai cosa che sanno anche i sassi. Le peculiarità e gli stilemi manifestati da questo genere musicale nel vecchio continente vantano, infatti, una precipua caratteristica, quella di vantare interpreti la cui preparazione esecutiva è di livello assoluto, anche se a volte, e questa può essere l’unica pecca, se così vogliamo definirla, viene invece a mancare l’originalità compositiva, la sostanza materica del costrutto sonoro, come se ci fosse ancora, a livello inconscio, il blocco che coglie il fratello minore di fronte all’ammirazione incondizionata che prova nei confronti del fratello maggiore, pur non essendo inferiore a lui in fatto di genialità e brillantezza.
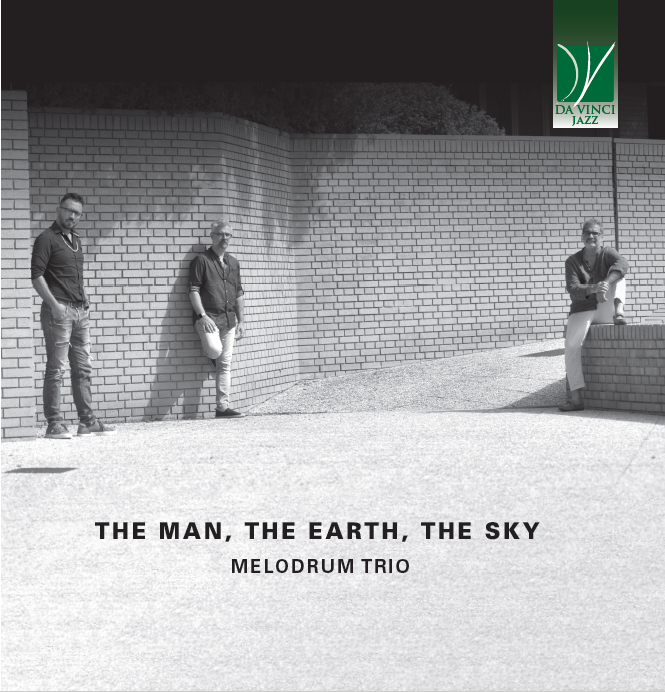
Genialità e brillantezza che, tornando nella sfera del jazz nostrano, non mancano invece fin dal primo ascolto al Melodrum Trio, composto da Salvatore Spano al pianoforte, da Salvatore Maltana al contrabbasso e da Francesco Brancato alla batteria e percussioni, il quale ha registrato per la Da Vinci Jazz il disco The Man, the Earth, the Sky. Questo è il loro terzo progetto discografico e rappresenta, in un certo senso, il risultato di una maturazione ormai acquisita, a fronte di una ricerca che nei due CD precedenti è scesa indubbiamente a patti con l’altro genere musicale squisitamente colto, ossia quello legato a ciò che definiamo grossolanamente e impropriamente “musica classica”. Difatti, se il primo loro disco, Perspectives (risalente al 2015), è stato da loro dedicato ad alcune figure femminili del mondo della lirica, e il secondo, Tony’s Dream (pubblicato tre anni dopo), è stato ispirato alla rielaborazione astratta del visionario mondo musicale di Antonio Vivaldi, The Man, the Earth, the Sky è la tipica crosta che viene staccata da una ferita ormai guarita, vale a dire una sedimentazione protettiva che non ha più ragione di essere davanti alla consapevolezza di mezzi non solo espressivi, ma anche e soprattutto compositivi, non più smaccatamente debitori verso un altro genere.
Si badi bene, ascoltando anche questo loro terzo lavoro, quel genere continua ad aleggiare, ma non ha più la funzione di una mucca dalle cui mammelle deve essere spremuto il latte linfatico di una genesi creativa affinché il risultato abbia un suo perché. Che il Trio in questione abbia nel suo DNA una matrice classica lo si comprende benissimo, ma ormai da intendere come proiezione più che come scheletro costitutivo della loro musica; facendo riferimento a un esempio nobile, quello del leggendario The Modern Jazz Quartet, è come se Salvatore Spano incarnasse lo spirito di John Lewis, la cui formazione classica e l’amore sviscerato e incondizionato nei confronti della musica bachiana venuta a patti con la dimensione sputatamente jazzistica di Milt Jackson, Percy Heath e Kenny Clarke, con il preciso compito di fare lo stesso nei confronti di Salvatore Maltana e Francesco Brancato, la cui formazione musicale, al contrario, è votata anima e corpo al jazz. Ma ciò che riesce a formulare in ambito compositivo il Melodrum Trio è più basato sull’incontro, piuttosto che sullo scontro, come invece avvenne per The Modern Jazz Quartet, ossia che l’opera di mediazione stilistica appare più organica, più naturale e più fluida.

Ecco, ascoltando il loro terzo lavoro, ciò che balza subito all’orecchio è proprio tale fluidità, la capacità di amalgamare la grande lezione classica con le esigenze nette, tagliate di netto di una musica che delle tematiche jazz fa la sua virtù incontrastata. Se ascoltate quanto fatto da John Lewis e compagni, noterete sempre la presenza di una gabbia “polifonica” che costringeva di fatto al quartetto di dare vita a meravigliose composizioni che facevano puntare lo sguardo all’ascoltatore su un passato più o meno remoto, cosa che invece non avviene con i tre artisti del Melodrum Trio: la lezione c’è, ma non crea una gabbia compositiva ed espressiva. Semmai è l’incontro di più linguaggi che si armonizzano idealmente in uno solo, e quindi consiglierei di ascoltare The Man, the Earth, the Sky partendo proprio dall’ultimo brano che, emblematicamente, s’intitola Esperanto, la cui potenza semantica si estrinseca proprio nel blend armonico in cui il costrutto defluisce naturalmente da un afflato classico, dato dal pianoforte di Spano che riecheggia fuggevolmente alle Goldberg Variationen bachiane, a una dimensione jazz senza la presenza di forzature, di cristallizzazioni, di fissazioni momentanee da un genere all’altro, poiché il passaggio dall’uno all’altro quasi non si avverte, tale è la capacità compositiva messa in atto.
Insomma, fluire, dare senso a una continua liquidità timbrica ed espressiva, può essere la parola d’ordine con la quale approcciarsi a questo disco. E questa cifra, il genoma che governa la musica dei tre artisti nostrani sono palpabili anche in quei brani in cui l’esigenza “sperimentale” ha voluto dire la sua: si prenda come esempio principe Alma Hundida (Para Thomas), la cui presenza, nella seconda parte del brano, di un frammento dell’appello politico-sociale registrato da Thomas Sankara (al tempo della presidenza del Burkina Faso) ha la medesima funzione di sovrastruttura inserita nella struttura sonora, tipica nella filosofia compositiva di un musicista geniale e rivoluzionario come Franco Evangelisti, uno dei patri putativi della Nuova Consonanza, il quale, tra l’altro, ebbe un fecondo rapporto con il genere jazz. In questo caso, l’interazione del costrutto musicale è tale che l’intromissione del frammento vocale vanta lo stesso risultato, cioè un dato il cui ascolto offre connotati naturali, in quanto la sovra-struttura non deturpa minimamente nella sua forzatura temporale la bellezza a-temporale così ottenuta: questo avviene quando la sperimentazione è al servizio di un fine musicale che non vuole offendere, ma solo offrire, lasciando sbocciare un fiore che è frutto della natura o non di un laboratorio.
E poi, sempre in chiave sperimentale-mediatrice, brani come l’iniziale Sequenza in blu, in cui l’incipit è l’immergersi in un’atmosfera sonora data dalle voci bianche che fa da apertura del sipario per introdurre l’irruzione del sound del Trio, capace di traslare da un coinvolgente costrutto ritmico, dato proprio dal primo brano, per poi passare quasi magicamente a dimensioni più distese, un’orizzontalità capace di trasformarsi in una soffice verticalità, come avviene nel pezzo che segue, Libre, mentre Elevation, il cui impatto primario rimanda alle raffinatezze timbrico-ritmiche dei Weather Report, ci fa comprendere come i tre interpreti siano stati capaci di dispensare con equilibrio e con l’onnipresente fluidità i loro interventi solistici. A tale proposito, credo proprio che la lezione classica immessa da Salvatore Spano nel linguaggio jazz del Trio sia rappresentato da tale peculiarità: il saper bilanciare, miscelare, immettere nella fitta o rarefatta struttura musicale la presenza “virtuosistica” dei rispettivi strumenti che emergono linearmente, con un’estrema naturalezza espressiva senza che l’assolo possa essere qualcosa d’altro-da-sé, in quanto esso non ha il compito di isolare chi lo esegue, ma quello ben più pregnante di continuare quanto elaborato di comune accordo (da qui si capisce ciò che intendevo prima, quando ho fatto presente che il comporre da parte del Melodrum Trio è sempre un primario atto di incontro e non di scontro, come avveniva con i componenti de The Modern Jazz Quartet, con le volontà stilistiche di John Lewis che dovevano fare i conti con l’altra faccia creativa rappresentata dagli altri tre elementi).

Quindi, l’estrema validità di The Man, the Earth, the Sky risiede in un ideale mix di vari elementi: a partire dalla straordinaria attitudine esecutiva dei tre artisti, che diviene creta perennemente modellata dall’altrettanto coinvolgente capacità creativa, in grado di dare vita a un incessante gioco di pesi e contrappesi tra momenti di assieme ad altri d’assolo (per questo motivo, chi mastica anche la musica classica dovrà ascoltare questo lavoro avendo a mente gli equilibri di un quartetto per archi); inoltre, l’uso intelligente, ma non elitariamente intellettuale, della sperimentazione, ossia con il Trio che, usandola, sputa in faccia alle trite e ritrite seghe mentali o, peggio, cercando dei coups de théâtre fini a se stessi: sperimentazione come comunicazione, come desiderio di donare emozione, al punto che gli effetti dati dalla presenza del Coro “Voci Bianche Lasalliane” di Grugliasco, l’irruzione della voce di Thomas Sankara, così come quella di Michela Atzeni, attrice, doppiatrice e performer nel brano Shunka Manito, arricchiscono tutto il costrutto come se rappresentassero un “quarto” strumento che sostiene, indica, illustra.
Consigliato non solo a chi ama il jazz, ma anche a chi capisce di musica tout court.
Alessandro Taricco e Gianpiero Ferrando hanno fatto un ottimo lavoro per ciò che riguarda la presa del suono: la dinamica è piacevolmente veloce ed energica, con un adeguato decadimento degli armonici e scevra da colori indesiderati; ne trae quindi vantaggio il parametro del palcoscenico sonoro, con una ricostruzione ottimale dei tre artisti nello spazio sonoro, così come l’intervento delle voci bianche e quelle chiamate in causa, il tutto contrassegnato da una discreta profondità e da una ragguardevole irradiazione del suono in altezza e in ampiezza. L’equilibrio tonale è altrettanto valido, in quanto sia nei momenti d’assieme, così come in quelli di assolo il registro medio-grave e quello acuto sono sempre precisi e denotano pulizia, in modo da far apprezzare maggiormente la fluidità compositiva ed espressiva del costrutto musicale. Infine, il dettaglio è oltremodo materico, capace di trasmettere la fisicità degli strumenti.
Andrea Bedetti
Melodrum Trio - The Man, the Earth, the Sky
Melodrum Trio (Salvatore Spano - pianoforte, Salvatore Maltana -contrabbasso, Francesco Brancato -batteria e percussioni)
CD Da Vinci Jazz C00678


