Disco del mese di Gennaio
Anche chi si occupa di critica musicale, come il sottoscritto, ha le sue umane debolezze, le sue irrinunciabili preferenze, le sue aderenze esistenziali che a volte prendono forma ideale nelle fattezze di un genere o di una composizione. E ogni volta che si accede in tale bacino di riscontro artistico è come tuffarsi nella placida immobilità di un supremo liquido amniotico che, per quanto mi riguarda, assume i contorni della trascrizione, il tutto corroborato da una “temperatura” altrettanto ideale, quella data dal pianoforte a quattro mani (non è forse vero che il Dio assoluto della Trascrizione, Johannes Brahms, trascrisse buona parte del suo catalogo per pianoforte a quattro mani?).
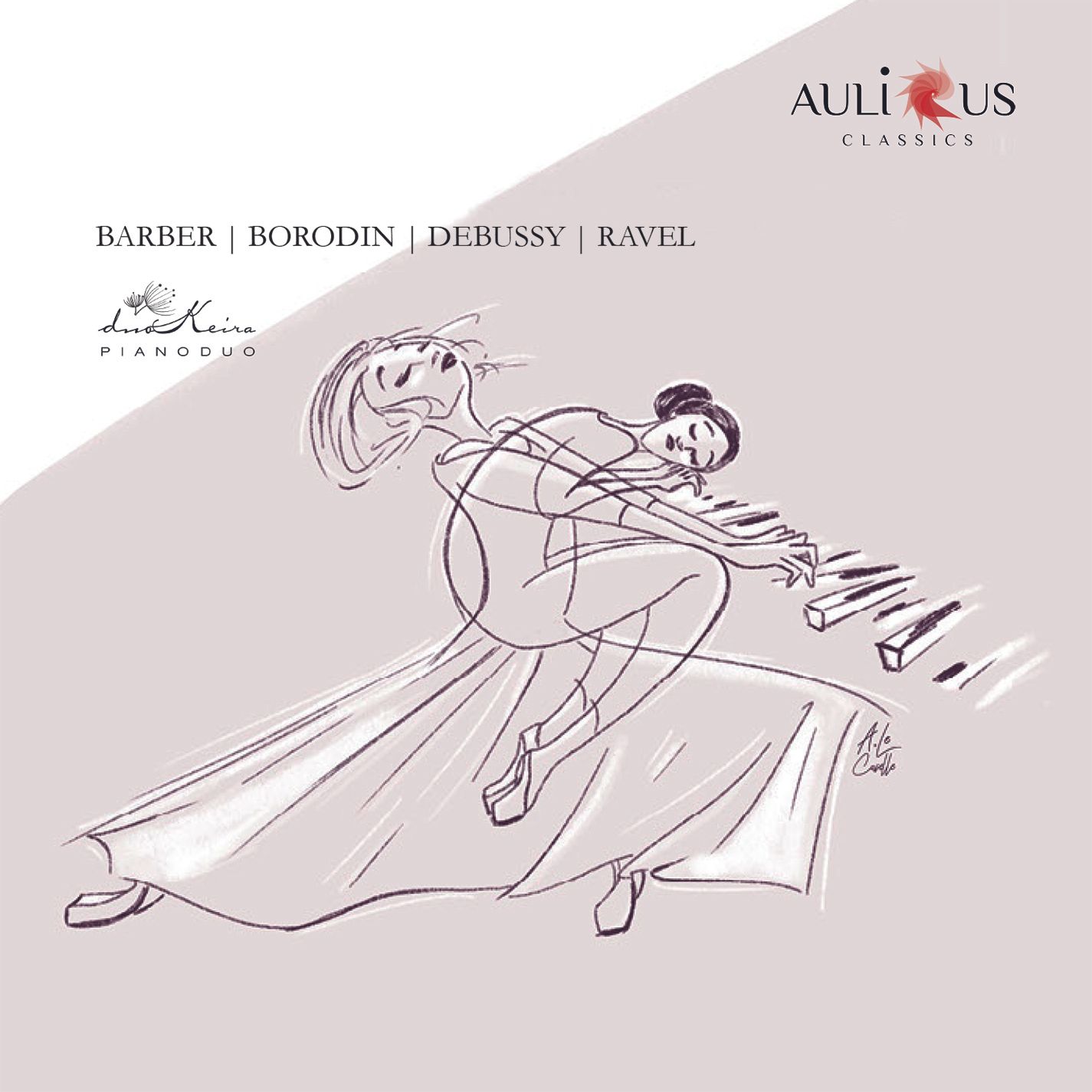
Alla luce di ciò, non deve quindi meravigliare se, qualche tempo fa, quando la pianista Sabrina De Carlo, che con la collega Michela Chiara Borghese forma il duo pianistico DuoKeira, mi ha contattato per sapere se fossi interessato alla loro ultima registrazione, dedicata a trascrizioni di brani orchestrali celebri, ho risposto favorevolmente, poiché il richiamo del liquido amniotico in oggetto si era inevitabilmente ridestato in me. Una scelta, quella del sottoscritto, che è stata a dir poco saggia e illuminante, come si andrà a leggere. Il disco in questione, pubblicato dalla Aulicus Classics, vede quindi il DuoKeira presentare una rara pagina di Samuel Barber, Souvenirs op. 28, le Danze polovesiane del chimico-compositore Borodin e due trascrizioni per pianoforte a quattro mani di quel nano geniale che è stato Maurice Ravel, il Prélude à l’après-midi d’un faune di Debussy e il Boléro dello stesso Ravel.
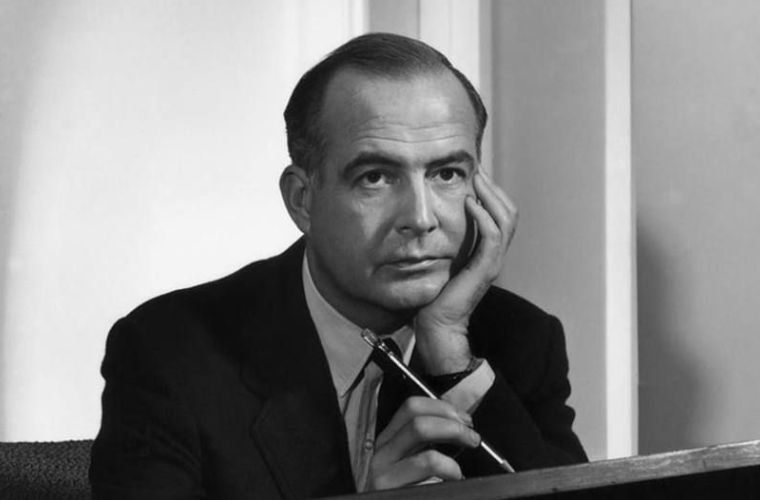
Andiamo per ordine. La prima bella notizia è che i Souvenirs di Barber sono una composizione esente dalla presenza del celeberrimo e annoso Adagio, che il musicista americano considerò una sorta di prezzemolo della situazione, insufflandolo a destra e a manca in alcune sue opere. La pagina in questione, invece, è una Suite di danza che l’autore scrisse nel 1951, un divertissement, come la definì lo stesso Barber, in sei distinti, brevi segmenti, ambientata nel 1914, alle soglie della Prima guerra mondiale, nel salotto del Palm Court dell’Hotel Plaza di New York. Un ambiente da jet society, che rimanda inevitabilmente alle atmosfere tanto care a Scott Fitzgerald, magari impegnato a dare la caccia all’irrequieta consorte Zelda, tra Martini cocktail e sigarette turche, zeppo di comodi divani dove illanguiditi rappresentanti della up town restano perennemente in attesa di qualcosa, come gli aristocratici romani al tramonto dell’impero attendevano l’arrivo dei barbari scrivendo acrostici indolenti, citando un verso verlaineiano. E al centro vi è una pista da ballo, dove gli eletti della società newyorkese ballano cheek to cheek o un mesto tango. Ma il tonale Barber trasforma questa visione apparentemente idilliaca, degna di un futuro Truman Capote sculettante mentre è impegnato a organizzare il Black and White Ball proprio al Plaza, con il quale festeggiare l’ultima puntata del suo romanzo più celebre, In Cold Blood, in una scena distorta, sfalsata, una sorta di tenero J’accuse verso l’alta borghesia del tempo attraverso un interessante uso dissonantico, tale da dare l’impressione di una fotografia sfuocata, con i tratti indistinti delle persone e delle cose e con le danze che assumono dei contorni che risultano essere quasi macabri. Si sente odore di stantio nel dipanarsi dei temi, dolci, nostalgici e contropelo allo stesso tempo. Una pagina “classica”, ma anche moderna, intrigante, che l’anno successivo venne orchestrata e il cui balletto fu rappresentato nel 1955 nella stessa New York.

Lo so, a molti piacciono le Danze polovesiane, ma provate ad ascoltarle due volte di seguito e poi ne riparleremo; si tratta, diciamolo a chiare lettere, di un brano, suddiviso in quattro tempi, alquanto stucchevole, denso di orpelli coloristici, perfino sdolcinato, figlio e frutto di un Oriente visto dall’Occidente più con l’immaginazione che con la realtà, erede in un certo senso di quelle “turcherie” con le quali si abbeverarono diversi compositori del Settecento, a cominciare dal divino salisburghese, per dare un senso piacevolmente decodificato del bisogno di esotismo e di terre lontane (a tale proposito, meglio leggere Baudelaire che ascoltare l’ottocentesca Lakmé di Delibes). Ma la merda può anche diventare cioccolato e le nozze di Cana in questione sono date dall’intervento di Nikolaj Sokolov, non per nulla allievo di Rimskij-Korsakov, il quale trascrisse, all’ombra del Circolo Beljaev, le Danze Polovesiane per pianoforte a quattro mani da cui il mercuriale Michel Fokine trasse il balletto rappresentato a Parigi nel maggio del 1909. Il pianoforte a quattro mani ha la benedizione di essere una rassicurante lente di ingrandimento capace di tirare fuori da una composizione la sua reale essenza armonica, prima ancora che melodica: e ciò accade esemplarmente in questo brano, scevro dei suddetti orpelli orchestrali e condensato in una linea ritmica che restituisce un senso di futura modernità tale da anticipare quello che farà poi Stravinskij con Le sacre du printemps. Certo, qui il senso ritmico è ancora rotondo, armonioso, sognante, rispetto alle pregnanti spigolosità che porteranno a épater le bourgeois sotto la bacchetta di Pierre Monteux.

Se Leo Longanesi si definì, con la sua spietata ironia, un “nano sott’odio”, da parte sua Maurice Ravel (Jean Echenoz, nella biografia romanzata che ha dedicato al compositore francese, scrive «Come Faulkner, ha il formato di un fantino, e quando, durante la Grande Guerra, lo vediamo percorrere impavidamente gli Champs-Elysées a bordo di un enorme autocarro militare - un piccoletto affogato in un pastrano blu e avvinghiato a un volante troppo grosso -, l’ilarità si mescola all’ammirazione») è un nano in cui alberga, satura, la genialità sotto ogni aspetto, anche nel côté della trascrizione di opere proprie e altrui e qui, nella versione del pianoforte a quattro mani, abbiamo il Prélude à l’après-midi d’un faune di Debussy e il suo Boléro, con i quali fa il suo trionfale ingresso l’eros. Da un lato Mallarmé preso di peso e trasformato in seducenti suoni (i centodieci versi del poema diventano le centodieci battute della composizione), dall’altro una Spagna che una volta tanto non è l’assolata, immobile, riarsa terra contemplata sotto un patio da Antonio Machado, ma il simbolo di un erotismo prorompente, di una seduzione che si fa carne, in cui Dioniso, grazie alla disciplina armonica di Ravel, veste a pennello i panni di un Apollo alla prova del viagra.

Visto che si tratta di musiche adattate o nate per il balletto, come si fa a non ascoltare la pagina di Debussy senza avere in mente la seducente figura di Nižinskij nei panni del fauno nell’omonimo balletto andato in scena nel 1912 a Parigi con le sue coreografie? Sia la musica nella versione orchestrale, sia il balletto sono messaggeri di un movimento fisico sempre più rallentato, destinato a un soave immobilismo di piacere, come quello rappresentato dal Maithuna d’ascendenza tantrica. Questo immobilismo erotico, in cui il sogno del fauno diviene possesso metaforico di una ninfa e in cui il giacere con lei significa possederla senza muoversi, viene ulteriormente esaltato dalla versione pianistica a quattro mani (che cos’è, in questo caso, la tastiera condivisa da due interpreti, se non un talamo sonoro?). Certo, si perdono le sfumature timbriche date dallo strumento solista, il flauto-membro, si dileguano le atmosfere umide e palpabili come l’epidermide ninfea agognata dal fauno, ma la rarefazione data dal pianoforte aumenta l’impatto dell’immagine tel quel, con il dipinto sonoro che perde i connotati dettagliati e acquatici di un Félix Vallotton per assumere quelli di un Kazimir Malevič, squadrati, titillati da un cubismo nel quale l’occhio ancora non si disperde.

Con il Boléro il Maithuna debussyano si trasmuta e aderisce alla “via della mano sinistra”, colonna sonora delle gesta di un Aleister Crowley, un inno al ritmo di un coito che parte da lontano, perfettamente incarnato dalla bellezza algida di Ida Rubinštejn, dominante su un tavolo, bramata ed esplorata immanentemente dai ballerini disposti intorno a lei, una Salomé straussiana che rinnega il sangue per concentrarsi sul seme che arriva, finalmente, dopo centosessantanove volte dal bacino ritmico dato dall’andamento ipnotico del brano. Ancora una volta, la versione per pianoforte a quattro mani focalizza ulteriormente tutto ciò, esaltando allo spasimo la dimensione spaziale di questa composizione, con la tastiera che, a poco a poco, si avvicina sempre più verso l’ascoltatore, come il gesto del coito che si fa sempre più veloce e possente. Perché il Boléro deve prima di tutto inebriare, deve rompere il quadro della realtà (come il teatro di un Antonin Artaud particolarmente in forma), frantumare il Super Io per far sì che l’Harry Haller dello Steppenwolf di hesseiana memoria possa infine conoscere i piaceri della carne, dopo essersi lasciato andare al ritmo sincopato di un fox-trot (in questo senso, c’è un’opera lirica del Novecento che incarna idealmente tale visione, l’immaginifica Jonny spielt auf di Ernst Křenek).

La lettura fatta dal DuoKeira è davvero entusiasmante, lo scrivo senza mezzi termini. Vediamone i motivi; prima di tutto l’assoluto dominio della materia musicale. Qui, non si tratta solo di proprietà tecniche e di affiatamento, ma di qualcosa di più: è la capacità di essere uno che si scinde in due, ossia due mani che diventano quattro mani gestite da una mente artistica in grado di separarsi per essere autonoma in due parti uguali. Questo genera un respiro musicale che è all’unisono, in quanto la separazione della tastiera del pianoforte in due parti distinte nella realtà dell’espressione artistica si annulla a favore di una concezione esecutiva che si raggruma in una proiezione comune. Tenete conto che tutti i brani presenti in questo disco sono irti di difficoltà tecniche, che inevitabilmente potrebbero inficiare la resa espressiva, non solo a livello di rispetto della partitura in sé, ma soprattutto per ciò che riguarda lo spirito che le anima (e questo vale soprattutto per le due trascrizioni di Ravel). Ma la fluidità, la naturalezza, la spontaneità che il duo formato da Sabrina De Carlo e da Michela Chiara Borghese riesce a ottenere va ben oltre la semplice capacità di sormontare tali difficoltà presenti nelle partiture in essere, poiché qui stiamo a un livello superiore, quello del reale, corretto afflato da donare ad ognuna di esse. Penetrare nella partitura come si penetra la persona amata, ossia trasmettere un atto d’amore e di totale realizzazione del sentimento che si prova nei confronti dell’oggetto amato. E di amore qui ce n’è tanto, tantissimo, un amore che si estrinseca nel saper restituire le arcate generali di ogni opera, quella relativa al Boléro è a dir poco impressionante, tenuto conto che gli oltre quindici minuti della durata della composizione sono una simbolica ed esaltante ascesa timbrica parcellizzata istante dopo istante, con un timbro che è sempre perfettamente relativo a quello dell’altra interprete (da qui si comprende una mente che si scinde in due e due mani che diventano quattro), al punto da credere che ci troviamo di fronte a un fenomeno di “artiste siamesi”. E poi la caratura psicologica della resa sonora, lo scavare nella forma per estrarne la linfa, il succo che la irradia; sia nei Souvenirs di Barber, sia, soprattutto, nel Prélude à l’après-midi d’un faune di Debussy la resa psicologica (si noti l’uso parsimonioso della pedaliera, come a dire che le sfumature sono date da suoni esenti da forzature o manomissioni, così come un pittore che riesce a donare nuances alla tela con pennellate precise e allo stesso tempo perfettamente scontornate, definite eppure trasognate, inclini a stimolare l’immaginazione di chi la ammirerà). Questa proprietà di scandagliare psicologicamente la partitura, con un’ideale calibrazione del gesto pianistico, permette di conseguenza di ricreare nell’ascoltatore lo spazio evocato dalla musica stessa (queste partiture, nel bene e nel male, sono squisitamente evocative, poiché create ad uso e consumo anche della rappresentazione di danza), ergo, devono impressionare, una musica a programma che si fissa nel movimento e nella plasticità di chi le danza. Ma qui ci troviamo di fronte a una trascrizione pianistica, la cui efficacia risiede nella capacità, a dir poco indispensabile, di ricreare idealmente e interiormente lo spazio fisico nel quale si dipana la struttura sonora, come per l’appunto accade nei Souvenirs, dove le sfumature “intere” date dal timbro generato ricreano la sala e coloro che calpestano la pista da ballo, e nel Prélude debussyano (in quest’ultimo c’è poi da considerare il perfetto bilanciamento che il duo in questione riesce a evocare tra lo strumento solista, il flauto, e l’accompagnamento orchestrale, dando così vita a un ulteriore spazio nello spazio). Una registrazione ineludibile, quindi, per capire che cosa significa interpretare. Folgorazione illuminante.
La presa del suono è stata effettuata da Simone Sciumbata e di primo acchito può lasciare perplessi, in quanto, a livello di palcoscenico sonoro, il pianoforte, uno splendido Fazioli F278, è posto oltremodo in profondità, fornendo di conseguenza una proiezione fisica dello strumento che presenta uno spazio circostante assai voluminoso, sia in fatto di lontananza e di altezza, sia in fatto di ampiezza tra i due diffusori. Ma ascoltando la resa artistica delle due pianiste si comprende poi meglio come tale distanza possa essere effettivamente di aiuto per apprezzare e sondare meglio proprio lo spazio fisico che si pone tra strumento e ascoltatore grazie alla lettura del duo, in quanto in tale modo, anche grazie a un’apprezzabile dinamica energica, il suono generato diviene “spettacolo” in sé; quindi, permettendo una visualizzazione della musica che non deve essere solo “ascoltata”, come si è già fatto presente, ma anche “vista”. A livello di equilibrio tonale, il risultato è buono, anche se i registri, soprattutto quello medio-grave, risultano essere leggermente “secchi”, quando invece il suono generato da un Fazioli risulta essere più rotondo, più sfumato, maggiormente ricco di armonici, anche se qui il loro decadimento risulta essere corretto e non sfalsato. Da ultimo, il dettaglio riesce, per i motivi addotti, a fornire una considerevole dose di nero intorno al pianoforte, tale da rendere oltremodo materico lo strumento, senza affaticare la fase di ascolto.
Andrea Bedetti
AA.VV. – Barber | Borodin | Debussy | Ravel
DuoKeira (Michela Chiara Borghese & Sabrina De Carlo) (pianoforte)
CD Aulicus Classics ALC 0057
Giudizio artistico 5/5
Giudizio tecnico 4/5

