Tra le tante immagini stereotipate che affliggono il mondo della musica colta occidentale, una delle più battute, oltre ad essere una delle più becere, è quella secondo la quale il pianismo di Béla Bartók sia ascrivibile a un percussionismo forsennato, un utilizzare il pianoforte come se fosse l’incarnazione di una batteria di timpani sui quali picchiare a più non posso. Sublime potenza dell’imbecillità, tenuto conto, se si ascolta con più attenzione e, soprattutto, con più umiltà la musica del sommo magiaro, che il suo comporre, sempre restando nell’ambito dello strumento in questione, quello prediletto, anche per via del suo status di interprete, a dir poco formidabile (si deve forse ricordare che nel 1905 Bartók giunse secondo al Premio Rubinstein, al tempo il concorso pianistico più prestigioso al mondo, dietro a un certo Wilhelm Backhaus?), è il frutto del suo essere un sismografo che cammina, personalità eclettica imbevuta di una sensibilità emotiva ed etica come poche lo sono state non solo nel Novecento, ma in tutta la storia della musica cosiddetta classica.
E allora, se in Bartók il pianoforte e la sua scrittura sono il termometro con il quale misurare la sua temperatura creativa, si noterà per forza di cose che sovente la febbre “barbara” (aggettivo, come si vedrà, da prendere con le dovute pinze per ciò che riguarda l’estetica che governa la sua opera generale) lascia altrettanto spesso periodi nei quali la tachipirina compositiva volge a una sorta di rarefatta serenità d’intenti, non stilistici, ma espressivi. Questo perché il pianismo bartókiano oltre ad essere “percussivo” (termine orrido ed abominevole) sa anche volgere, a tratti, in un bouquet che si potrebbe avvicinare a un Brahms, quello lirico, eppure severo, rigoroso, non nella mera costruzione armonica, sia ben chiaro, ma nella sua intenzionalità esplorativa. Il sommo magiaro, casomai non fosse abbastanza chiaro (e qui mi rivolgo ai cosiddetti apostoli del percussivismo) è stato difatti uno dei più straordinari esploratori del linguaggio musicale del Novecento, non solo a livello innovativo, ma anche sotto l’aspetto di un sincretismo d’idee, di sensazioni, di raffigurazioni desunte da un ferreo e appassionato approccio antropologico, ancor prima che etnomusicologico.
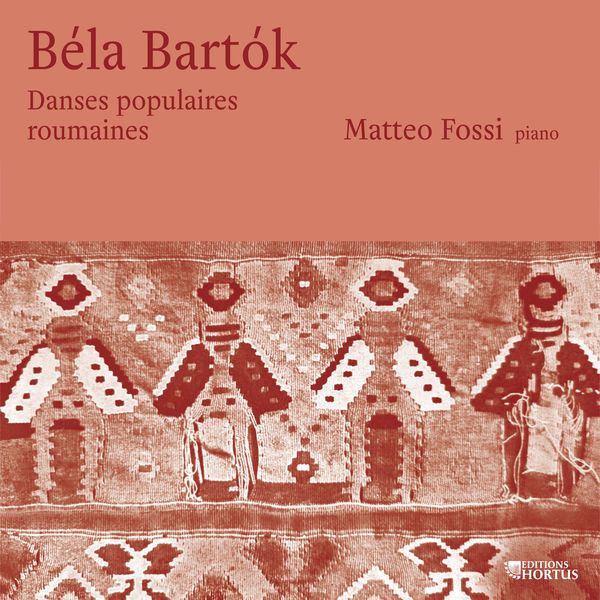
In fondo, chi interpreta e, di riflesso, chi ascolta la musica bartókiana, dev’essere prima di tutto capace di coglierne il senso dell’antropologia dell’anima che la anima, che la intride, che la modella. Tale processo di acquisizione, nell’interprete e nell’ascoltatore, vede le sue origini su come Béla Bartók, in qualità di etnomusicologo, si avvicinava alle fonti musicali popolari da ascoltare, da registrare e da metabolizzare; se si osservano con attenzione quelle poche immagini catturate durante i suoi viaggi nei piccoli centri rurali dei Carpazi, si vedrà come il compositore ungherese cercasse prima di tutto d’immergersi nel milieu della comunità di cui era ospite, di come, ancor prima del suono, cercasse di ascoltare la realtà che lo circondava, che fosse un’aia, un cortile, una stanza, un luogo comune nel quale i contadini del posto si incontravano per suonare e cantare. Da etnomusicologo, Bartók recepiva e fissava il suono prodotto, l’ultimo anello della catena, ma da “antropologo dell’anima” cercava soprattutto l’origine remota di quel suono, di quel brano, desideroso di coglierne l’immagine di una poesia popolare, quella che alberga nel tempo vissuto dall’uomo umile, che si rapporta con le stagioni, con il mutare dei raccolti, che vive e sperimenta il quotidiano attraverso la continua decodifica di segni che appartengono al suo humus antropologico.

E questa e la medesima etica che si può cogliere in buona parte della musica del compositore magiaro, la cui opera è inscindibile dal concetto di un rapporto continuo con altrettanti segni, e non solo stilistici, che albergano nelle sue pagine, soprattutto pianistiche. Segni che lo portano non solo a toccare, ma anche a immaginare suoni di quel folklore da lui studiato e amato. Ecco, perché accanto al Béla Bartók etnomusicologico sul campo, esiste parallelamente quello che lo è nell’immaginazione, nella formulazione ideale e idealistica di un suono da lui ricreato eticamente. E quando Bartók fa musica sulla base di una ricerca sonora squisitamente etica, allora il risultato armonico ed espressivo dà luogo a una forma stupendamente poetica, che si nutre e si avvale di quella poesia esistenziale che il compositore cercava, quasi con ossessione, in quelle realtà rurali, emarginate, isolate da lui raggiunte e indagate.
Mi piace immaginare, a mia volta, che questo sia stato lo spirito, la molla, prima ancora che interpretativa, etica che ha spinto uno dei pianisti italiani più interessanti e stimolanti, Matteo Fossi, a dare vita a un ennesimo progetto discografico culminato in un viaggio nella musica pianistica di Béla Bartók, quella aderente ai principi etnomusicologici, ma io preferisco definire con il termine “antropologici dell’anima”, che presenta brani collegati appunto ad essi e che porta il titolo di Danses populaires roumaines, pubblicato dalle Éditions Hortus. In questo disco, il pianista fiorentino ha voluto esplorare musicalmente otto momenti pianistici del compositore magiaro, i Tre canti popolari del distretto di Csik, del 1907, la prima delle Due danze rumene, del 1909-10, le Due Elegie, del 1908-09, l’Allegro barbaro, del 1911, le Danze popolari rumene, del 1915, la Suite op. 14, del 1916, le Sei danze su ritmo bulgaro(tratte dal Sesto libro dei Mikrokosmos), del 1939, e le Otto improvvisazioni su canti contadini ungheresi, del 1920. Pagine celebri, come l’Allegro barbaro, la Suite e le Danze popolari rumene che si vanno ad innervare con le altre meno famose, ma non per questo meno coinvolgenti. Un programma che, a sua volta, considero alla stregua di un sentiero attraverso il quale Matteo Fossi ha voluto incastonare sia un approccio didattico nell’universo “etnomusicologico” del compositore ungherese, sia un’immagine etica, come già accennato sopra, che deriva da esso (e questa, a ben vedere, è la stessa impronta che contraddistingue le sue precedenti registrazioni discografiche, tutte all’insegna di una didattica che si stempera in quadri che possono essere osservati con l’udito nel loro descrittivismo espressivo).

Seguo ormai da anni il percorso interpretativo del pianista fiorentino e sulla base dell’ascolto delle sue registrazioni discografiche posso affermare che due sono i cardini sui quali si fonda, rigore ed espressività. E anche questo suo ultimo lavoro dedicato alle composizioni “etnomusicologiche” di Béla Bartók segue il medesimo principio. Ma il problema con il compositore ungherese è che non solo si dev’essere tecnicamente ed espressivamente in grado di renderlo al meglio, perché per rispettare la sua musica pianistica bisogna innanzitutto amarlo. E che Matteo Fossi ami il pianismo di Bartók non si discute. Cominciamo dal brano più celebre, quell’Allegro barbaro, che in un certo senso ha anticipato e preparato il terreno al ben più tellurico Sacre du Printemps di Stravinskij (le due opere vennero eseguite in prima assoluta a pochi mesi l’una dall’altra), e che per via della pericolosa semanticità che si cela dietro quell’aggettivo ne ha pagato un pegno, un prezzo indubbiamente alti. Matteo Fossi si rende conto di ciò e la sua lettura di questo breve pezzo, ma di una densità capace di sfidare quella di un buco nero, non vuole assolutamente essere semplicemente un rude e implacabile martellio sulla tastiera, un’esaltazione alle orde di Attila o di Gengis Khan, come si scrisse ai tempi da parte di critici scandalizzati (fesserie senza senso), ma la ricerca, l’esplorazione, che parte da quelle istanze di ambito dell’“antropologia dell’anima”, un sondarne i colori che la rivestono, incluse le asperità timbriche, le quali sono il risultato di un superamento dal pianismo lisztiano e da quello debussyano. E il “barbarismo” apparente che grava a livello semantico, sembra ammonirci il pianista fiorentino, non ha nulla a che fare con quello stravinskijano, poiché se quest’ultimo esalta nel suo Sacre l’immagine di un paganesimo che impregna la tradizione rurale russa, Bartók, da parte sua, vuole solo presentare i connotati panteistici che impregnano la ruralità balcanica, desunti proprio dalla sua ricerca antropologica-musicologica. E il bandolo della matassa, e questo vale non solo per l’Allegro barbaro, ma anche per le altre composizioni qui registrate, viene dato da Fossi attraverso una continua esposizione della poetica presente in esse, una poetica che dev’essere snidata nel proporre la musicalità che forma il loro DNA.
Si prenda la Suite, esempio perfetto di quel folklore del tutto “immaginario” che il compositore magiaro viveva dentro di sé, emblema assoluto della sua traboccante ammirazione verso la dimensione della “comunità”, antitetica a quella di “società”, che Matteo Fossi ricostruisce attraverso una sonorità che vive della sua agogica, nel senso che oltre ai tempi dati dalla partitura ci sono anche quelli “interiori” (ecco perché per rendere idealmente il pianismo bartókiano bisogna anche amarlo), con i quali bisogna sempre fare i conti per restituire l’“immagine” (si ascolti il terzo tempo, l’Allegro molto, e la sua progressione timbrica data dal registro grave). Anche qui c’è la dimensione percussiva, ma il pianista fiorentino, giustamente a mio avviso, non la forza, non la rende brutalmente tellurica, ma emanazione di quel panteismo che circonda e impregna la comunità che la persegue anche attraverso l’apporto dato dai canti e dalle canzoni popolari, tramandate di generazione in generazione. E qui subentra, immancabilmente, la concezione didattica in Bartók, l’insegnare che si manifesta attraverso il proprio percorso di apprendimento, perché non si può essere docente se non si è anche discente. Così, tutta la dimensione musicale del compositore magiaro è un dare e ricevere, che porta a un equilibrio sottilissimo reso, scolpito, dispensato magistralmente nella sua opera pianistica.
Cosa che avviene puntualmente anche nelle Sei danze su ritmo bulgaro, summa della didattica incarnata dai Mikrokosmos, che prende avvio su un apprendimento (il cosiddetto “ritmo bulgaro”) per dare corpo all’insegnamento (la danza) che però non dev’essere resa solo attraverso le indicazioni date dalla partitura (ricordiamoci che siamo al sesto e ultimo libro dei Mikrokosmos, quello più impervio, setaccio implacabile tra chi sarà e non potrà essere pianista all’altezza), ma anche dando modo all’interprete di aggiungere un suo tasso di improvvisazione, ossia di “immaginazione”. Un’“immaginazione” che Matteo Fossi dispensa sapientemente, rispettando la forma, ma donandole vita, pulsazioni, ritmi (non solo “formalmente bulgari”), ma ancora grazie all’apporto di un’agogica che arrotonda, smussa, imprimendo una virata che tende alla musicalità più schietta e appassionata.

È un peccato che non vengano proposte più frequentemente le Otto improvvisazioni su canti contadini ungheresi, la cui caratura compositiva le rende un unicum nel panorama dei primi decenni del Novecento pianistico. Ed è altrettanto ovvio, sulla base di ciò che si è scritto, che Matteo Fossi possa andarci a nozze, in quanto qui la dimensione dell’“immagine” folklorica arriva a un punto massimo di resa espressiva, basata su un suono che deve concretizzarsi su una continua sospensione timbrica (ma quanta modernità si cela dietro questa composizione?). Sospensione che deve fare i conti con un fraseggio che però non deve diventare una trappola per l’interprete, come se la tastiera fosse una tagliola che non deve scattare a causa di una possibile ricerca ossessiva delle melodie che sono annidate in essa. Così come, al suo opposto, la ricerca timbrica, l’esplorazione dei colori che formano il suo divenire, non devono trasformarsi in un mantra assoluto, poiché in fondo Béla Bartók è uno che ricerca non per rompere, ma per continuare. Ebbene sì, il compositore magiaro sa anche essere un “tradizionalista”!
Un tradizionalista che sa cesellare un capolavoro assoluto nella sua essenzialità temporale (appena sei minuti totali) quali sono le sei Danze popolari rumene, di cui la prima è l’emblema di una sensualità vaporosa, eterea, triste e gioiosa contemporaneamente, come solo la musica slava sa farlo, che viene continuata a singulti nelle altre cinque che seguono. Qui, Matteo Fossi sprigiona un’agogica che è un movimento rappreso, quasi fosse un incedere timoroso ma mai difettante, un fluire cinematografico fissato fotogramma dopo fotogramma, con una timbrica che dovrebbe essere insegnata per quanto viene scolpita in modo folgorante, quasi trovasse un tempo (già, quello “interiore”!) con il quale allungare a dismisura quello fissato sulla partitura, al punto da annullarlo magicamente.
Altre due gemme sono le Elegie che si dipanano complessivamente per quasi diciassette minuti, uno degli ultimi retaggi (l’ultimo?) che il genio magiaro riservò all’animus romanticus, frutto di una delle sue annose fregature sentimentali, e il cui seme viene interrato e innaffiato in un campo ben diverso nel quale il potassio che lo arricchisce è a cura di un’azienda, quella chiamata Novecento, che permette non al compositore, ma anche all’interprete di mettere becco, di dire la sua, secondo la sua coscienza e la sua “immaginazione”. Ecco spiegata la puzza di spettralità, la rarefazione esasperata del suono che si sprigiona (mi viene in mente la visione di un recluso che cerca di scappare in ogni modo possibile dalla cella in cui è rinchiuso), di un Béla Bartók che urla, muto, il suo dolore, il suo essere abbandonato e che demanda all’esecutore di aggiungere il suo carico da quaranta, substrato che va a gravare ulteriormente sullo strato timbrico che forma una microscopica era glaciale capace di raggelare noi che l’ascoltiamo. Ora, la lettura che Matteo Fossi fa della seconda Elegia, la più enigmatica, è votata proprio a restituire la glacialità che si irradia progressivamente nel tessuto armonico, una lastra di ghiaccio che si forma sulla spinta del registro grave, con la mano sinistra che diviene emissaria del “generale inverno”. Ma allo stesso tempo, fa in modo che la mano destra dipani un segmento ipnotico, dalle dita del quale sfuggono stille di speranza, di una luce intravista e che si insegue per disperazione (ed è qui che il rubato che rompe l’imene del “quasi improvvisando”, come richiesto sulla partitura, è a cura dell’interprete che se ne fa letteralmente carico). E il pianista toscano di carico ne mette a iosa, in fatto di espressività, di lucida demarcazione tra ciò che può essere detto e ciò che dev’essere, nonostante tutto, ancora taciuto, lasciando all’ascoltatore, a sua volta, di continuare il sentiero iniziato dal compositore.

Potrà sembrare paradossale, ma l’ideale conclusione di questo viaggio dedicato all’immagine della poesia nella musica popolare in Bartók può essere data dal brano iniziale, ossia i Tre canti popolari del distretto di Csik; poco meno di tre minuti, ma che riassumono tutto quanto si è detto e spiegato. Ascoltateli e vedrete riassunta tutta la concezione estetica bartókiana, il suo essere pianista, il suo essere etnomusicologo (antropologo dell’anima) e il suo essere didatta. Ed è per questo motivo, forse, che Matteo Fossi ha voluto iniziare con essi, e non solo per motivi puramente cronologici. Perché ascoltando con attenzione, si possono cogliere in accordi, in segmenti di pochissimi secondi quanto poi verrà approfondito in seguito, come se fossero le “istruzioni per l’uso” che ogni interprete e ogni ascoltatore, che veramente amano la musica del genio magiaro, devono tenere a mente per entrare nel suo meraviglioso e sconfinato universo musicale.
La presa del suono è stata effettuata nella Concert Hall Fazioli di Sacile a cura di Luca Ricci ed è di ottima fattura. Come quasi sempre accade nelle registrazioni fatte in questa sala, la ricostruzione del pianoforte (uno splendido Fazioli, strumento che è in possesso di un timbro pieno nel registro grave e di un registro acuto all’insegna di un’incantevole cristallinità) avviene a debita profondità, senza però che si perda nulla in fatto di dettaglio e di messa a fuoco. Questo perché la dinamica è oltremodo sontuosa, sferzante, atomica, così come la microdinamica è in grado di enunciare armonici il cui punto di decadimento è un manuale di correttezza. Anche l’equilibrio tonale non è da meno, visto che la possanza del registro grave e la già citata cristallinità di quello acuto sono sempre perfettamente distinguibili, scontornati ottimamente. Infine, il dettaglio è un inno alla matericità, visto che la messa a fuoco dello strumento è palpabile, nonostante la ricostruzione del pianoforte sia stata fatta, come si è già detto, a una congrua profondità.
Andrea Bedetti
Béla Bartók – Danses populaires roumaines
Matteo Fossi (pianoforte)
CD Éditions Hortus 203
Giudizio artistico 5/5
Giudizio tecnico 4,5/5

