Un artista con il suo strumento. Questo è un mondo dal quale l’artista cerca di uscire per dare fisicità al suo volere interpretativo e nel quale l’ascoltatore cerca di entrare per identificarsi, nei limiti della sua sensibilità, con quanto l’artista intende trasmettere. Fin dai tempi remoti, a cominciare dall’immagine del dio Pan con il suo flauto creato da un pezzo di canna, ci accompagna soprattutto l’idea, l’immagine, la rappresentazione di un musico che si unisce al suo strumento a fiato, relegato nel suo mondo di suoni interiori ed esteriori, mondo conchiuso in sé, esploratore ramingo e solingo (lo psicologo James Hillman, tornando alla figura di Pan, asserisce che per via della sua figura ripugnante può essere definito il dio della masturbazione, dell’amore non procreativo, rappresentante di una veicolazione erotica che è attiva e passiva al tempo stesso, un Narciso che non si contempla, ma che si soddisfa da solo).
Chi suona uno strumento a fiato non può anche cantare, per questo i filosofi dell’antica Grecia, Platone e Aristotele su tutti, e i Padri della Chiesa, Agostino d’Ippona e Severino Boezio su tutti, lo condannano, definendo empio il suo emettere suoni. D’altronde, chi soffia dona simbolicamente vita, oltre a frantumare il principio di un ordine divino, trasmesso dal μέλος, dall’atto del canto, il quale foneticamente traccia una precisa semantica nella quale riconoscersi. Donare vita ed essere semanticamente non tracciabile, una maledizione che chi suona gli strumenti a fiato si porta mitologicamente, teologicamente, socialmente addosso e che la storia, in un certo senso, ha voluto sempre relegare in una posizione antropologica di sudditanza rispetto a chi, invece, dapprima suonava e cantava allo stesso tempo, e di chi poi ha imbracciato uno strumento ad arco o si è seduto davanti a una tastiera. Non soffiava e non “si masturbava”, lasciando così al flautista il compito di incarnare la figura di un Onan musicale. Rispetto ad altri interpreti che si confrontano con il loro strumento, è chi soffia che si sente più solo, più escluso, più distaccato dall’oggetto che lo circonda.

Quest’idea, questo sentore di solitudine alla quale è costretto colui che emette suoni con il fiato, impegnato a dare vita togliendo un pezzetto della sua vita, mi è venuta in mente ascoltando il primo disco registrato da solista dalla flautista genovese Antonella Bini, la quale ha inciso per l’etichetta tedesca Zeitklang Edition un album che porta il titolo di Illuminanz, il quale raccoglie otto composizioni di autori contemporanei per solo ottavino, flauto e flauto basso, tre delle quali sono state appositamente scritte per lei. I brani in questione sono Je vous parle d’un temps… per flauto solo di Simone Fontanelli, Illuminanz per flauto solo di Bernfried E. G. Pröve, Aria di Beatrice per flauto basso, voce di contralto ed electronics di Gerard Pape, Dia nykta per flauto solo di Fausto Romitelli, Excenter V per flauto solo di Bernfried E. G. Pröve, Douze monologues pascaliens per flauto solo di Nicolas Bacri, Sphinx (Thema 3) per ottavino di Art-Oliver Simon e Thoughtsper flauto solo di Marco Reghezza.
Questi otto brani, nelle rispettive concezioni dei loro autori, rappresentano un ideale frammento di una contemporaneità musicale che mira a incontrarsi o a scontrarsi con quanto la circonda: sia ben chiaro, qui non si parla o si raffigura esclusivamente una dimensione reale, fattiva, empirica dell’altro-da-noi, ma anche e soprattutto quanto avviene nel dentro-di-noi, a cominciare da quanto viene costruito dall’asse creatore e ricreatore, ossia compositore e interprete, con il primo che intende formulare un preciso (o meno) stato d’animo e con il secondo destinato a ripercorrerlo, proponendo a sua volta una sovrastruttura del tutto personale e individuale, quella che mira a ispessire, ad ampliare il seme iniziale, poiché una sensibilità ha sempre bisogno di un’altra sensibilità per essere tale. È quanto succede proprio con il pezzo Je vous parle d’un temps… per flauto solo di Simone Fontanelli, dedicato ad Antonella Bini, nel quale abbiamo un perfetto esempio di una speculazione sonora (il compositore milanese è anche un filosofo), la cui essenza/esistenza si plasma inevitabilmente con il DNA interpretativo preposto, quello della stessa flautista genovese, che con il suo strumento ha un compito ineludibile, quello di insufflare, di volta in volta, uno scontorno alla materia sonora proposta dal suo autore, così come i pensieri che cercano di dare una forma allo stato d’animo di chi li crea e li porta alla superficie.

Del compositore tedesco Bernfried E.G. Pröve Antonella Bini presenta due brani, Illuminanz ed Excenter IV (quest’ultimo dedicato a lei), con il primo che assomma precisi rapporti volumetrici a una ricerca la cui matrice spettrale rappresenta una sorta di lente di ingrandimento. Qui, al di là del gesto tecnico, l’interprete deve andare oltre ai canonici atti gestuali, utilizzando le labbra quasi per esprimere suoni, fonemi, interloquendo in modo diverso con l’ancia dello strumento. In Excenter IV lo spazio circostante viene sondato anche dalla presenza degli electronics, i quali però non sono da intendere come intervento distinto dal flauto stesso, ma come materializzazione altra dell’indistinto emanato dallo strumento a fiato. Un gioco di alter ego, di maschere sonore che sembrano quasi non riconoscersi, manifestandosi come un reciproco eludersi, sfuggendo dall’altro per affermare (ma è proprio così?) un’autonoma esistenza, suffragata da accenni di una metodologia melodica che però non prende mai forma intesa come sopravvento di sopravvivenza.

La sfida dell’esistere come ricerca della materializzazione della forma si annulla prodigiosamente nel brano Aria di Beatrice per flauto basso, voce di contralto ed electronics del compositore francese Gerard Pape (dedicato anch’esso ad Antonella Bini), pezzo di straordinaria complessità ed arditezza tecnica, con la flautista che deve modulare un suono frutto di sincretismo tra soffio e canto, atto totalizzante che deve ricreare in altro spazio/tempo quanto avviene nel XXX canto del Purgatorio, probabilmente il più ermetico nel rapporto significante/significato di tutta la Commedia dantesca, con l’irruzione di Beatrice e il conseguente allontanamento-distacco di Virgilio. Canto dalla pregna dimensione psicoanalitica, dunque (non si dimentichi che Pape è anche uno psicoanalista di formazione lacaniana), proiettato nell’atto di accusa del personaggio femminile (veicolazione del timore) e del conseguente pentimento da parte del poeta (acquisizione del tremore). La spazialità è la ragnatela nella quale la voce/soffio assume nettamente i contorni di un ruolo operistico, ectoplasma teatralizzante, in cui si crea un’atmosfera fluttuante (il rimbalzare volumetrico degli electronics è fondamentale in ciò), la cui solidità arriva solo a sfiorare l’elemento liquido. Tale impalpabilità si proietta nell’atto del lamento (sembra quello di un coro da tragedia greca, nel quale il canto è dato dall’uno che simboleggia il tutto) e con lo strumento a fiato che diviene elemento amplificante della voce (fellatio sonora che raggiunge vertici di un auto-erotismo in cui Beatrice viene tentata/allettata dall’archetipo dio Pan, colui che cantando punisce). Brano magmatico, la cui indistinzione perenne richiama gli elementi formativi del teatro di Antonin Artaud, un articolarsi divinamente atroce nella sua lunghezza (quasi venti minuti di durata), festival di una staticità in continuo divenire, capace, infine, di irradiare un’incredibile liricità che viene incastonata nella sua idealizzazione operistica.
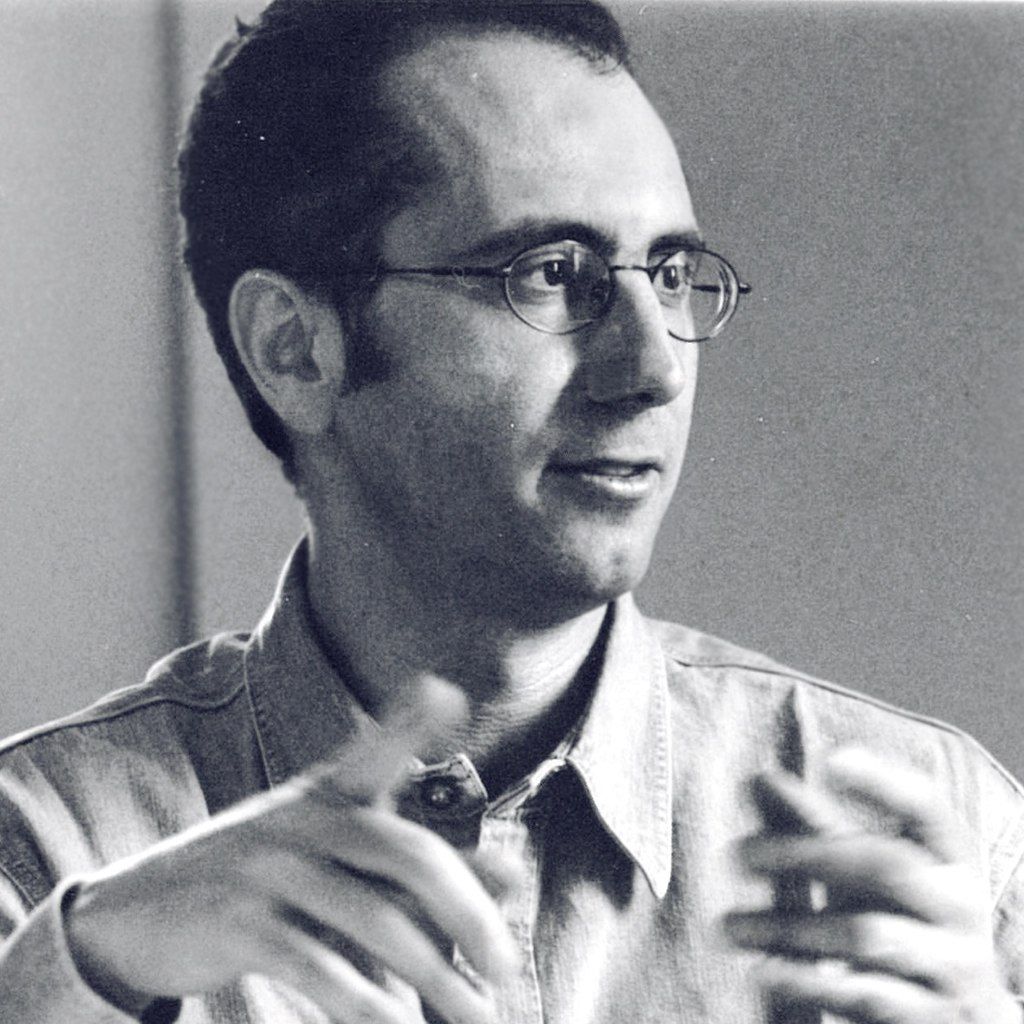
Scomparso a soli quarantuno anni, il goriziano Fausto Romitelli, allievo tra gli altri di Franco Donatoni e di Gérard Grisey, pone invece in contrasto, come metafora del concentus, nel brano Dia nykta la voce e il soffio dell’interprete, mantenendoli sempre distinti come entità e sfere contraddistinte: il decorso, lo svolgimento si questo articolarsi tra suoni e fonemi assume quasi i contorni di una disputatio medievale, un articolarsi controdialettico in cui le cesure presenti risultano essere la chiusura e la conseguente apertura di una novella disputa o, forse, l’ulteriore sviluppo di quanto avvenuto in precedenza, come la pietra che Sisifo è costretto continuamente a far rotolare dalla rupe.
Dalla non comunicabilità all’asserzione individuale, pienamente autonoma e autoproclamante data dai Douze monologues pascaliens per flauto solo del parigino Nicolas Bacri, la cui complessità tecnica viene continuamente parcellizzata dallo svolgimento dialettico, evocativo dato dal suono, il quale temporalmente risulta essere inattaccabile, inclassificabile («La mia musica non è neoclassica, è classica, perché conserva l’aspetto senza tempo del classicismo», ha affermato lo stesso Bacri), con un ritorno prepotente dell’immagine di Pan, capace di resistere al mutare delle epoche, immobile nel canneto, figura astorica, ma in grado di adattarsi, come testimonia la musica del compositore francese, di esprimersi attraverso una notevolissima flessibilità formale, data dall’alternarsi dei dodici tempi utilizzati in quest’opera, ognuno diverso dall’altro.
L’entità altrettanto sfuggente della figura mitologica data dalla Sfinge si delinea perfettamente nell’uso che il compositore tedesco Art-Oliver Simon fa dell’ottavino nel brano Sphinx (Thema 3); un rendersi sfuggente che è connaturato al registro acuto e sovracuto dato da questo strumento, la cui espressività non è mai disgiunta da un precipitarsi acustico che ne consegue. Qui, la difficoltà viene aumentata anche dall’intervento dell’interprete, che deve usare ancora la voce dando vita a una specie di “terzo suono”, un ibrido che fissa un ulteriore elemento sfuggente nella pianificazione altrettanto sfuggente di tutto il brano. L’ultimo pezzo, Thoughts per flauto solo del sanremese Marco Reghezza è un concentrato di virtuosismi e di notevoli difficoltà che si dipanano attraverso la formulazione e la concatenazione di tre segmenti A, B e C che hanno il compito di dare vita a una complessa architettura, fatta di esposizioni, debiti richiami e inserimenti in nome di un impianto armonico di considerabile fattura.

Questa prima registrazione solistica da parte di Antonella Bini non è da considerare come una sorta di consacrazione, in quanto la flautista genovese non ne aveva assolutamente bisogno, poiché il suo ruolo all’interno dell’Ensemble ACHROME, così come la sua instancabile opera di ricercatrice e di indagatrice nell’esplorare il suono di tutti gli strumenti che appartengono alla famiglia del flauto lo testimoniano abbondantemente. Semmai, questo disco ha il merito di evidenziare un altro aspetto, quello di una debita testimonianza di come la musica contemporanea considera e sfrutta questo strumento a fiato, il suo rapporto di affidamento e di espressività, le sue capacità di adattamento alle necessità e ai bisogni impellenti dati dalle nuovissime forme di creatività musicale. Bisogni che da parte sua Antonella Bini riesce a rendere perfettamente manifesti, conchiusi, atti risolutori di una fede interpretativa che è soprattutto espressione di amore/ammirazione verso il flauto e il suo suono. Ogni brano di questo programma è l’emanazione di un filamento che racchiude in sé un nervo scoperto, una testimonianza esemplare di quanto fa la musica contemporanea e di come un interprete deve annetterla nella sfera di competenza delle sue peculiarità tecniche e sensibili. E per quanto riguarda la musica destinata alla famiglia del flauto pochi, pochissimi interpreti possono vantare la tecnica e la sensibilità di Antonella Bini. Sbaglierebbe colui che volesse credere che Illuminanz vuole essere una manifestazione di virtuosismo, di “bravura”, di voler semplicemente far capire come si possa dare del tu alla musica che si affronta. Semmai, è proprio il contrario, ossia l’atto di fede di un’artista che osa offrire la propria umiltà, vale a dire la capacità di saper aderire alle cose che intende rappresentare ed esprimere. È, prima di tutto, una volontà intellettuale, spirituale, speculativa che si tramuta in suono, di un’interprete che non perde mai di vista la maledizione che incarna, quella del dio Pan, facendo sì (e ci riesce benissimo) che le sue manifestazioni di un sublime onanismo artistico possano finalmente vantare e sbandierare un’assertività, una consapevolezza a tutto tondo che una componente della musica contemporanea continua a proporre e a presentare.
Alla luce di ciò, sono convinto che ogni volta che Antonella Bini soffia nel suo flauto, il dio Pan sorride compiaciuto al riparo del suo canneto.
Karsten Scholz ha effettuato un’ottima presa del suono, contraddistinta da una considerevole dinamica, sempre pregna di energia, di velocità nei transienti e di una più che sufficiente naturalezza. Il palcoscenico sonoro ricostruisce in tutti i brani l’artista al centro dei diffusori, con una presenza posta a una discreta profondità nello spazio esecutivo. Di apprezzabile fattura l’equilibrio tonale, con i registri dei tre strumenti utilizzati sempre debitamente scontornati (quello acuto e sovracuto dell’ottavino non raggiunge mai punti di fastidiosa saturazione), mentre il dettaglio è carico di matericità, oltre a non costringere mai ad un ascolto stancante.
Andrea Bedetti
AA.VV. – Illuminanz
Antonella Bini (flauto, flauto basso e ottavino)
CD Zeitklang Edition EZ-73071
Giudizio artistico 5/5
Giudizio tecnico 4/5

