Che cosa sarebbe della creazione di un compositore se non ci fosse poi l’interprete che la esegue? Di certo questa è una domanda retorica, se non pleonastica, ma ogni tanto è meglio porsela per non dimenticare che spesso, come la storia della musica lo insegna, il processo transitivo che dal segno (ossia il compositore) porta al suono (ossia l’interprete) non rappresenta solo una dovuta e necessaria concatenazione, ma diviene anche un atto di affinità, di condivisione ideale tra chi crea e colui che poi ricrea. Così, ricordando quanto affermò Goethe, vale a dire che non bisogna mai chiedere a chi ci ascolta se è d’accordo con noi ma, piuttosto, domandargli se anche lui segue il nostro stesso sentiero, ecco che nel momento in cui l’affinità e l’intendimento tra chi crea e chi ricrea li porta a intraprendere e a seguire un sentiero comune, si viene a creare un unicum il cui risultato è un atto artistico compiuto, completo, circolare e non lineare.
E che l’incontro tra il compositore, liutista e chitarrista tedesco Hans-Jürgen Gerung e il chitarrista Andrea Monarda rispecchi fedelmente quanto auspicato da Goethe risulta a dir poco lampante se si ascolta il disco, appena pubblicato dalla EMA Vinci, Andrea Monarda plays Hans-Jürgen Gerung, in cui il virtuoso pugliese interpreta alcune pagine per sola chitarra del musicista germanico, per la precisione …und bleibst so lang ich bleibe da Hölderlin im Turm, Lichtpunkte, La commedia dell’arte e Fraginesi, le quali forniscono all’ascoltatore una visione precisa della concezione estetica di colui che è stato dapprima allievo e poi amico di Sylvano Bussotti.
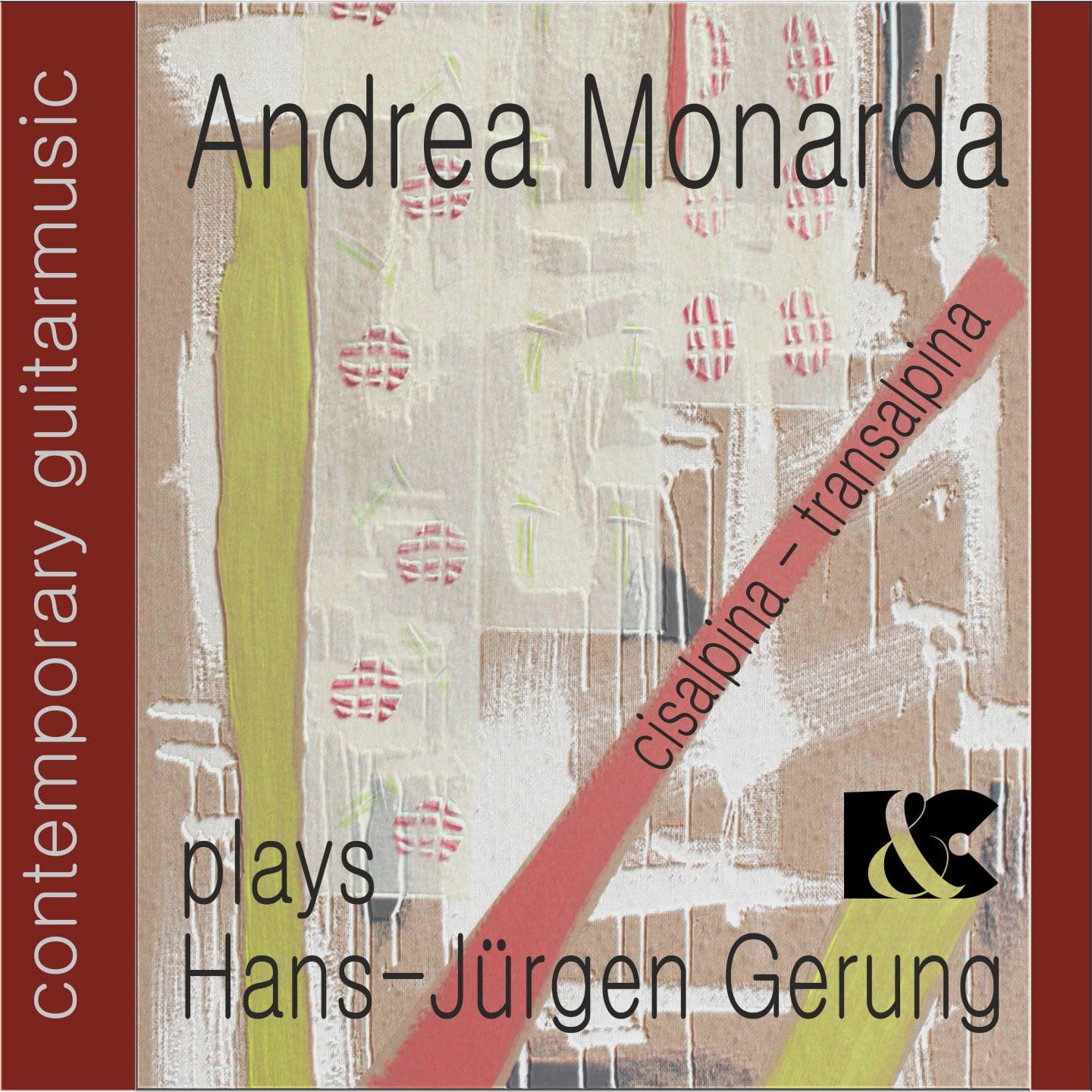
Come ricorda Renzo Cresti, il più illustre specialista italiano di musica contemporanea, nelle note che accompagnano il disco, è stato lo stesso Gerung a spiegare che «ci sono diversi modi per attraversare le Alpi, a piedi, in auto o in aereo, in questo CD le attraversiamo attraverso il potere della musica. Andrea Monarda è un artista che ha una grande affinità con l’arte e la cultura d’oltralpe. È stata sua l’idea di registrare un album con una selezione delle mie opere più importanti per chitarra. Il risultato è una collaborazione congeniale tra un virtuoso italiano e un compositore tedesco». Come a dire che il “potere della musica” riesce a portare a compimento un progetto in cui due sensibilità separate da un (presunto) ostacolo, rappresentato dalle Alpi, ma che simbolicamente assumono l’allegoria di ciò che divide implacabilmente durante il corso delle nostre traiettorie esistenziali, possono identificarsi l’una con l’altra, in cui l’altra è l’emanazione dell’una, la sua testimonianza e la sua cassa di risonanza.
Qui, l’identificazione è davvero totale, assoluta, in nome di un benefico δαίμων che perpetua nell’atto ricreativo il transfert tra Gerung e Monarda (quest’ultimo, è bene ricordarlo, è avvezzo al concetto del trans, in quanto laureato alla Facoltà per Interpreti e Traduttori dell’Università di Trieste, oltre ad essere anche traduttore militante). Quindi, anche considerando l’entità dei brani che compongono la tracklist del disco, non si può fare a meno di come, creando lo spartito, Gerung abbia fondamentalmente “tradotto” in musica elementi poetici (Hölderlin), paesaggistici (Lichtpunkte), teatrali (La commedia dell’arte) e geografici (Fraginesi), dando così modo ad Andrea Monarda di avviare un processo euclideo/traduttivo, ossia di una linea sonora che, nel suo perpetuarsi traducente da un punto di partenza ad uno finale, si perde implacabilmente nello spazio e nel tempo.

C’è anche un altro aspetto da tenere conto e che è già presente in altre opere di Gerung riservate non solo alla chitarra, quello che riguarda il suo incedere sonoro che si irradia nella dimensione spaziale in cui si viene ad attuare: tale incedere, che risente spesso e volentieri di altre espressioni artistiche, tra cui principalmente la pittura, della quale il musicista tedesco è appassionato cultore ed egli stesso pittore e disegnatore, si pone in una prospettiva che non è quasi mai assertiva, risolutiva, autoproclamante, ma votata a un’incessante e instancabile necessità di chiedere, di domandare, di sondare con il timbro dello/degli strumento/i quanto vi è attorno per capire e accettare. Ora, questo chiedere, questo domandare da soggetto ad oggetto si manifesta compiutamente soprattutto se a farlo è uno strumento come la chitarra, le cui corde permettono la realizzazione di tale atto reiterativo, con un suono che non è mai convulso, ostentato, sbattuto in faccia, ma sempre rispettoso e conscio del fatto di non incarnare una “risposta”. Per questo, affrontando le partiture di Gerung, il loro ascolto dev’essere altrettanto reiterativo, ripetuto nel tempo, per entrare maggiormente in assonanza con questo processo interrogativo, il quale cala come una pellicola trasparente sulle cose che osserva e che tenta di “decodificare” (teniamo sempre a mente il procedere traduttivo… ).
D’altronde, partendo dal brano dedicato alla poetica hölderliniana, non è forse un amore impossibile, come quello che ci fu tra Susette Gontard, madre del bimbo del quale il poeta tedesco fu precettore, e Hölderlin, allo stesso tempo una domanda che non può avere risposta? Non è forse, incarnato dallo stesso titolo …und bleibst so lang ich bleibe (ossia “… E rimani finché rimango io”), un qualcosa che si perpetua tramite l’immagine dell’altra finché l’uno vuole perpetuarla? È un’attuazione pressoché impalpabile, diafana, al limite della trasparenza, che viene tradotta in suono da Gerung attraverso una modalità altrettanto tenue, esitante, che rimanda tragicamente al rimbaudiano par délicatesse j’ai perdu ma vie o, ancora meglio, alla lapidaria sentenza di Yukio Mishima, l’amore perfetto è quello che non si realizza. Ecco, in ciò trovo che il compositore tedesco sia particolarmente attirato da ciò che non ha il potere di realizzarsi, di manifestarsi apertamente, di dichiararsi candidamente al mondo (se si osservano con attenzione i suoi disegni, si potrà notare che a dominare sono i pochi tratti essenziali, che permettono alla non-materia di essere appena materia, proprio come un amore che si sussurra per poi lasciarselo sfuggire tra le dita). Sulla base di ciò, il costrutto musicale che si dipana negli oltre otto minuti di questo brano non può che assumere quasi un sapore bergmaniano, ossia di sussurri timbrici che celano grida rapprese, sfumature, dominate e plasmate da Monarda, in cui si dibattono i tentativi di un sentimento predestinato al nulla.
Se l’amore può essere un ostacolo insormontabile se non si realizza secondo i nostri piani e le nostre aspettative, anche un ostacolo offerto e imposto dalla natura, come quello rappresentato da una catena montuosa diviene nella dimensione creativa di Gerung lo spunto per “tradurne” aspetti apparentemente reconditi e falsamente occultati. Il secondo brano, Lichtpunkte, suddiviso in tre tempi, Calmo - Senza tempo - Poco energico, che intende descrivere le montagne svizzere, rappresenta appunto ciò, con i “punti di luce”, come recita il titolo, che sono quelli che vengono riflessi dall’oscurità della notte e il loro cangiare nel corso della giornata, simbolo stesso di una trasmutazione perenne delle cose pur nella loro fissità imposta dalla natura. Un richiamo quasi eracliteo, nel rapporto che si viene a creare nella mobilità incastonata nell’immobilità, con la chitarra che diviene oggetto di immanenza per lanciare nello spazio barlumi di trascendenza.

Ora, il piatto della bilancia, quello che ospitava il doveroso richiamo culturale e naturale del Geist tedesco, nel corso del CD passa a quello che ospite invece il tributo che Gerung dona all’arte e alla cultura popolare italiana, perché l’Italia è indubbiamente la sua seconda patria, incarnazione vivente di quel grand tour che il genio espressivo germanico riversò, nel corso dell’Ottocento, oltre le Alpi per gettarsi tra le braccia del sole mediterraneo e della culla dell’antichità classica. Così, ecco il ciclo de La commedia dell’arte, il cui retaggio colmo di fantasia, di una favola che è narrata su un improvvisato palcoscenico, che sia una piazza di paese o quello di un teatro poco importa, diviene punto di approdo nel labirintico e assurdo costrutto teatrale contemporaneo, lacerazione di una speranza, finale di una partita mai iniziata. Un ciclo in cui si dibattono le tipiche maschere regionali del teatro popolare nostrano, Colombina, Arlecchino, Pagliaccio, Pantaleone e Capitano, introdotti da un Prologo, separati da quattro Intermezzi e conclusi da un Epilogo; qui, la chitarra di Monarda si trasforma in un Fregoli a sei corde, in una trattazione in cui la fisiognomica teatrale dei cinque personaggi viene esemplarmente eviscerata dalla trama timbrica, dalle improvvise variazioni che la loro psicologia e i loro caratteri impongono.
Infine, Fraginesi, diviso in quattro parti: Giardino - Cani - Forno - Silenzio; Fraginesi è un piccolo paese siciliano che si trova a una cinquantina di chilometri da Palermo, in cui si trova un tipico casale circondato da ulivi e alberi da frutto. Un luogo rimasto impresso nella memoria del compositore e chitarrista tedesco, il quale, in questa pagina, ha voluto eleggerlo a simbolo stesso di quella mediterraneità dalla quale sono attratti gli uomini nel cui sangue scorre il ricordo iperboreo. Da questa origine, da tali presupposti, il Sud viene visto con gli occhi di un bambino, palcoscenico ampliato, smisurato, in cui a dibattersi non sono più i personaggi di un teatro immaginario, bensì reale, con protagonisti profumi, sapori, emozioni che inevitabilmente dilatano i sensi e il loro afferrare ogni cosa per tramutarla in sensazioni. E sono proprio queste ultime a farla da padrone in questo ultimo brano, in cui la mediterraneità di Andrea Monarda si sovrappone e fa da Virgilio a quella evocata da Gerung nei panni di un novello Dante.
Nella cover del CD vi è un dipinto astratto contemporaneo, del quale non viene riportato il nome del suo autore, ma che rende perfettamente lo spirito, l’anima di questa registrazione, con macchie di colori tenui dominate da marcate pennellate di bianco, le quali accolgono una striscia trasversale rossa, sulla quale sono riportate le parole “cisalpina - transalpina”. Credo che tale immagine renda perfettamente l’idea di questo disco, come se si trattasse di un Tagebuch aus Italien di matrice sonora, lo sguardo di un viaggiatore incantato di leskoviana memoria che unisce in matrimonio la sua profonda cultura natale con quella di una seconda patria, grazie alla quale perpetuare il suo lavoro di “traduttore musicale”.
La presa del suono è stata effettuata da Mimmo Galoppa, il quale è riuscito a fissare assai bene il suono delle tre chitarre utilizzate da Andrea Monarda grazie a una dinamica più che apprezzabile, a un palcoscenico sonoro che scolpisce al centro dei diffusori in modo ravvicinato, ma non scorretto, il suono, e a un equilibrio tonale e a un dettaglio che non presentano difetti di sorta.
Andrea Bedetti
Hans-Jürgen Gerung – Andrea Monarda plays Hans-Jürgen Gerung
Andrea Monarda (chitarra)
CD EMA Vinci 70378
Giudizio artistico 5/5
Giudizio tecnico 4/5

